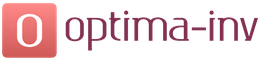Tabella delle malattie virali degli animali. Malattie virali del cane e del gatto
Test
"Virologia veterinaria"
Fattori specificiantiviraleimmunità
Il sistema immunitario specifico ha propri organi centrali (midollo osseo, timo, borsa di Fabricius negli uccelli, fegato nei mammiferi) e periferici (milza, linfonodi, tessuti linfoidi del tratto gastrointestinale, nonché sangue e linfa, che entrano e circolano continuamente tutte le cellule immunocompetenti).
L'organo dell'immunità è il tessuto linfoide e i suoi principali esecutori lo sono Macrofagi(così come altre cellule presentanti l'antigene), vari popolazioni E sottopopolazioni T- elinfociti Bov.
Il bersaglio principale del sistema immunitario sono gli antigeni, la stragrande maggioranza dei quali sono di natura proteica. I linfociti sono rappresentati da due grandi popolazioni: cellule B e T, responsabili del riconoscimento specifico degli antigeni. Essendo sorti da una fonte comune, la cosiddetta cellula staminale, e dopo aver subito un'adeguata differenziazione negli organi centrali del sistema immunitario, i linfociti T e B acquisiscono immunocompetenza, entrano nel sangue e circolano continuamente in tutto il corpo, svolgendo il ruolo dei suoi efficaci difensori.
I linfociti T forniscono la risposta immunitaria di tipo cellulare, mentre i linfociti B forniscono la risposta immunitaria di tipo umorale.
La differenziazione dei precursori dei linfociti T in cellule immunocompetenti (“formazione”) avviene nel timo sotto l'influenza di fattori umorali secreti dal timo; maturazione dei linfociti B - negli uccelli nella borsa, nei mammiferi, prima nel fegato fetale e dopo la nascita nel midollo osseo.
I linfociti B e T maturi acquisiscono la capacità di riconoscere antigeni estranei. Lasciano il midollo osseo e il timo e colonizzano la milza, i linfonodi e altri gruppi di cellule linfatiche. La stragrande maggioranza dei linfociti T e B circola nel sangue e nella linfa. Questa circolazione costante garantisce che il maggior numero possibile di linfociti rilevanti entri in contatto con l'antigene (virus).
Ciascuna cellula B è geneticamente programmata per produrre anticorpi contro un antigene specifico. Dopo aver incontrato e riconosciuto questo antigene, le cellule B si moltiplicano e si differenziano in plasmacellule attive che secernono anticorpi contro questo antigene. Un'altra parte dei linfociti B, dopo aver attraversato 2-3 cicli di divisione, si trasforma in cellule della memoria che non sono in grado di produrre anticorpi. Possono vivere per molti mesi e persino anni in base alla divisione, circolando tra il sangue e gli organi linfoidi secondari. Riconoscono rapidamente l'antigene quando rientra nel corpo, dopodiché le cellule della memoria acquisiscono la capacità di dividersi e trasformarsi in plasmacellule che secernono anticorpi.
Le cellule della memoria si formano dai linfociti T allo stesso modo. Questa può essere chiamata una “riserva” di cellule immunocompetenti.
Le cellule di memoria determinano la durata dell'immunità acquisita. Dopo ripetuti contatti con questo antigene, si trasformano rapidamente in cellule effettrici. Allo stesso tempo, le cellule B della memoria forniscono la sintesi di anticorpi in un periodo di tempo più breve, in quantità maggiori e principalmente IgG. È stato accertato che esistono cellule T helper che determinano il passaggio delle classi di immunoglobuline.
Esistono due opzioni per emettere una risposta immunitaria sotto forma di biosintesi degli anticorpi:
La risposta primaria avviene dopo il primo incontro dell'organismo con l'antigene;
Risposta secondaria - in caso di contatto ripetuto con l'antigene, dopo 2-3 settimane.
Differiscono nei seguenti indicatori: la durata del periodo di latenza; il tasso di aumento del titolo anticorpale, la quantità totale di anticorpi sintetizzati; sequenza di sintesi di immunoglobuline di varie classi. Anche i meccanismi cellulari delle risposte immunitarie primarie e secondarie differiscono.
Durante la risposta immunitaria primaria, si nota quanto segue:
La biosintesi degli anticorpi dopo il periodo di latenza dura 3-5 giorni;
La velocità di sintesi degli anticorpi è relativamente bassa;
Il titolo anticorpale non raggiunge i valori massimi;
Vengono sintetizzate prima le IgM, poi le IgG e successivamente le IgA e le IgE.
La risposta immunitaria secondaria è caratterizzata da:
Periodo latente - tra parecchie ore;
La velocità di sintesi degli anticorpi è logaritmica;
Il titolo anticorpale raggiunge i valori massimi;
Le IgG vengono sintetizzate immediatamente.
La risposta immunitaria secondaria è causata dalle cellule della memoria immunitaria.
Le cellule T hanno più popolazioni con funzioni diverse. Alcuni interagiscono con le cellule B, aiutandole a moltiplicarsi, maturare e formare anticorpi, oltre ad attivare i macrofagi - cellule T helper (Tx); altri sopprimono le risposte immunitarie - cellule T soppressorie (Tc); la terza popolazione di cellule T distrugge le cellule del corpo infettate da virus o altri agenti. Questo tipo di attività è chiamata citotossicità e le cellule stesse sono chiamate cellule T citotossiche (Tc) o cellule T killer (Tk).
Poiché le cellule T helper e le cellule T soppressorie agiscono come regolatori della risposta immunitaria, questi due tipi di cellule T sono chiamate cellule T regolatorie.
I macrofagi sono un fattore essenziale nell’immunità antivirale. Non solo distruggono gli antigeni estranei, ma forniscono anche determinanti antigenici per innescare una catena di reazioni immunitarie (presenti). Gli antigeni assorbiti dai macrofagi vengono scissi in brevi frammenti (determinanti antigenici), che si legano a molecole di proteine del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC I, II) e vengono trasportati sulla superficie dei macrofagi, dove vengono riconosciuti dai linfociti T (Tx, Tk) e linfociti B, che porta alla loro attivazione e riproduzione.
I T-helper, quando attivati, sintetizzano fattori (mediatori) per stimolare i linfociti B e T. Le cellule T killer attivate si moltiplicano e si forma un pool di linfociti T citotossici che possono garantire la morte delle cellule bersaglio, cioè cellule infettate da un virus. I linfociti B attivati si moltiplicano e si differenziano in plasmacellule, che sintetizzano e secernono anticorpi della classe appropriata (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE).
L'interazione coordinata di macrofagi, linfociti T e B quando incontrano un antigene fornisce una risposta immunitaria sia umorale che cellulare. Tutte le forme di risposta immunitaria richiedono l'interazione coordinata dei principali fattori del sistema immunitario: macrofagi, linfociti T, B, cellule NK, sistema dell'interferone, complemento, sistema principale di istocompatibilità. L'interazione tra loro viene effettuata utilizzando una varietà di mediatori sintetizzati e secreti.
I mediatori prodotti dalle cellule del sistema immunitario e coinvolti nella regolazione della sua attività sono collettivamente chiamati citochine (dal greco cytos - cellula e kineo - mettere in moto). Sono divisi in monokiS- mediatori prodotti da monociti e macrofagi; linfochine- mediatori secreti dai linfociti attivati; linfochine, che sono identificati chimicamente e ottenuti in forma pura. Nel 1979 fu proposto di chiamarli interleuchine. Sono designati da numeri: 1, 2, 3, 4, 5, ecc. La famiglia delle interleuchine viene riempita con nuovi rappresentanti che effettuano la regolazione reciproca del sistema immunitario, nervoso ed endocrino. Tutte le cellule immunocompetenti portano sulle loro membrane recettori unici, con l'aiuto dei quali riconoscono e percepiscono i segnali di altre cellule immunitarie, riorganizzano il loro metabolismo, sintetizzano o eliminano i propri recettori. Grazie a ciò, tutte le cellule del sistema immunitario funzionano come un sistema ben oliato.
Nella fase iniziale dell'infezione, di norma, il virus affronta i sistemi di difesa dell'ospite. La prima barriera protettiva è la pelle e le mucose del corpo. Se la loro integrità viene violata, entrano in gioco meccanismi di difesa aspecifici di emergenza (fattori di immunità innata). Tra questi, è particolarmente evidenziata l'attività antivirale dell'interferone, delle cellule NK (cellule natural killer) e dei macrofagi.
Effetto antivirale dell'interferone. L'infezione di una cellula con un virus provoca la sintesi dell'interferone. Sotto la sua influenza, vengono attivati i meccanismi protettivi delle cellule vicine, garantendo la loro resistenza infezione virale. L'interferone induce la sintesi di due enzimi: la proteina kenasi, che porta alla soppressione della sintesi delle proteine virali, e l'oligoadenilato sintetasi da 2", 5" che attiva l'endonucleasi, che distrugge l'mRNA virale. Inoltre, l'interferone attiva fortemente i macrofagi e le cellule NK.
Effetto antivirale delle cellule NK e dei macrofagi. Le cellule NK attive compaiono entro due giorni dall'infezione dell'ospite con il virus. Le cellule NK e i macrofagi distruggono le cellule infette. Principalmente le cellule NK svolgono la reazione di citotossicità cellulare anticorpo-dipendente (ADCC).
Se il virus riesce a superare le barriere della difesa innata, provoca lo sviluppo di una risposta immunitaria specifica con la comparsa di T-killer, T-helper e anticorpi antivirali. Gli anticorpi e i T-killer svolgono il ruolo principale nella risposta immunitaria. I principali meccanismi dell'immunità antivirale si riducono al blocco della diffusione delle particelle virali e alla distruzione delle cellule infette dal virus, ad es. cellule, che sono in realtà “fabbriche” per la produzione di nuovi virus.
La diffusione del virus nell’organismo è bloccata principalmente dagli anticorpi. Durante lo sviluppo dell'immunità specifica, vengono sintetizzati anticorpi contro la maggior parte degli antigeni virali. Tuttavia, si ritiene che l'infezione virale sia controllata principalmente da anticorpi contro le glicoproteine di superficie. Questi antigeni, spesso chiamati protettivi, sono localizzati sulla superficie dei virioni o espressi sulla membrana di una cellula infettata da un virus. I meccanismi dell'immunità antivirale umorale possono essere diversi. Il metodo per eliminare l'infettività delle particelle virali dipende dalla loro posizione: extracellulare o intracellulare.
Gli anticorpi, adsorbiti sulla superficie dei virioni, ne bloccano le funzioni vitali. Prima di tutto, si tratta di un blocco dell'attaccamento alla cellula ospite, della penetrazione in essa e della spogliazione del virus. L'adsorbimento degli anticorpi sulle proteine del capside non consente ad alcuni virus (virus del cimurro, del morbillo, ecc.) di penetrare da cellula a cellula mediante fusione. Inoltre, si ritiene che gli anticorpi, attivando il sistema del complemento, causino danni all'involucro di alcuni virus e blocchino i recettori cellulari dei virus. Tuttavia, attualmente questo processo non è considerato essenziale nella protezione antivirale.
L'azione degli anticorpi, oltre a neutralizzare i virus extracellulari, è quella di provocare la distruzione delle cellule infettate dal virus, attivando il sistema del complemento. Il secondo meccanismo d'azione degli anticorpi contro il virus intracellulare è la reazione di citotossicità cellulare anticorpo-dipendente effettuata dalle cellule NK. Gli anticorpi fissati sulla membrana di una cellula infettata dal virus entrano in contatto con le cellule NK (tramite il frammento Fc delle IgG), che uccidono le cellule infette utilizzando perforine e granzimi.
Nell’immunità alle infezioni virali, le cellule T svolgono una varietà di funzioni. Le cellule T helper svolgono un ruolo importante nella formazione di anticorpi in risposta agli antigeni, inoltre, queste cellule aiutano nell'induzione delle cellule T killer, nonché nell'attrazione dei macrofagi e delle cellule E nel sito dell'infezione virale e nella loro attivazione . Le cellule T killer svolgono la sorveglianza immunologica antivirale e agiscono in modo molto efficiente e selettivo, distruggendo le cellule infettate dal virus con l'aiuto di perforine e granzimi. Dopo essere penetrati nella cellula bersaglio, i granzimi attivano le endonucleasi attraverso una cascata di reazioni. Questo enzima promuove la rottura del filamento del DNA e lo sviluppo dell'apoptosi (morte cellulare programmata).
Meccanismi di “fuga” dei virus dalla sorveglianza immunitaria dell’organismo ospite. I virus hanno varie proprietà di protezione dal riconoscimento da parte degli anticorpi:
Ciò si ottiene nel modo più efficace mediante un cambiamento negli antigeni: un cambiamento nelle regioni immunodominanti avviene nelle proteine virali. La variabilità antigenica è osservata nei virus dell’immunodeficienza umana e nei virus dell’influenza. Pertanto, nel virus dell'influenza si parla di “deriva” antigenica (cambiamenti graduali) e “spostamento” (cambiamenti bruschi). L'immunità umorale a queste infezioni virali persiste solo fino alla comparsa di una nuova sierovariante dell'agente patogeno, che non consente di contare sull'effetto a lungo termine della vaccinazione;
Gli anticorpi possono rimuovere gli antigeni virali dalla membrana plasmatica cellulare mediante capping (aggregazione di molecole sulla superficie cellulare). Pertanto, i virus dell'herpes codificano per glicoproteine che legano gli anticorpi attraverso il frammento Fc, mentre l'attivazione del complemento viene interrotta e l'azione degli anticorpi antivirali viene bloccata;
numerosi virus (citomegalovirus, adenovirus, ecc.) inducono la produzione di proteine che sopprimono l'espressione delle molecole della classe MHC sulla membrana delle cellule colpite. Ciò dà al virus un vantaggio aiutandolo a evitare il riconoscimento.Questi singoli virus (herpesvirus) hanno geni per proteine omologhe ai recettori delle citochine. Di conseguenza, questi recettori “solubili”, come “trappole”, legano le citochine e ne neutralizzano le azioni;
alcuni virus (virus Epstein-Barr, adenovirus) sono in grado di contrastare l'effetto degli interferoni: producono brevi tratti di RNA che in qualche modo sopprimono l'attivazione della proteina chinasi;
molti virus sono in grado di indurre i macrofagi a produrre citochine soppressive che sopprimono lo sviluppo della risposta immunitaria.
Virus della bronchite infettiva aviaria
La bronchite infettiva (IB) è una malattia altamente contagiosa che si manifesta nei polli con la sindrome respiratoria e uremica e nei polli con danni agli organi germinali e diminuzione della produzione di uova.
La malattia è comune in tutti i paesi con un allevamento di pollame industriale sviluppato. Provoca enormi danni economici, consistenti in una diminuzione della produttività di carne e uova del 50-60%, morte di polli nel primo mese di vita fino al 30%, abbattimento fino al 60% di volatili durante il decorso cronico della malattia con complicazioni da infezioni batteriche.
In condizioni naturali, i polli di tutte le fasce d’età sono sensibili; I polli di età inferiore a 30 giorni sono i più suscettibili alla malattia. Una persona si ammala con lievi segni di danno alla tomaia vie respiratorie.
Caratteristiche dell'agente patogeno.
L'agente eziologico dell'IB è un virus a RNA appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. I suoi virioni isometrici, di dimensioni 70-120 nm, sono racchiusi in un guscio supercapside con rare sporgenze a forma di clava che ricordano la corona solare.
Tutti i ceppi del virus IB sono molto sensibili all'irradiazione UV; entro tre minuti vengono neutralizzati con soluzioni all'1% di fenolo, cresolo, formalina, soluzione al 70% alcol etilico. Nel liquido allantoico a meno 25°C rimangono attivi fino a 537 giorni.
Il virus presenta una variabilità antigenica significativa. Sono stati identificati 7 sierotipi. I ceppi isolati nel nostro Paese appartengono ai sierotipi Massachusetts e Connecticut. L’isolamento degli isolati sul campo che differiscono nella composizione antigenica da questi sierotipi spinge a lavorare per creare un nuovo vaccino.
Struttura antigenica. Le proteine virali differiscono nel tropismo dei tessuti. La patogenicità dei ceppi virali è associata ai punti isoelettrici delle loro proteine. La classificazione delle proteine basata su punti isoelettrici consente l'identificazione di ceppi altamente patogeni e persistenti. Sulla superficie del virus sono state trovate cinque agglutinine: A, B, C, D, E, di cui le prime quattro sono responsabili della neutralizzazione del virus. Dei 16 anticorpi monoclonali, tutti hanno reagito con le proteine del pepomero e un tipo di anticorpo ha neutralizzato l'infettività e ha soppresso l'attività emoagglutinante del virus.
L'infezione del pollame è accompagnata dalla formazione di anticorpi antiemoagglutinanti, neutralizzanti il virus e da un'immunità quasi permanente al tipo omologo di virus. Nei polli convalescenti sono stati rilevati anticorpi neutralizzanti il virus per 482 giorni. Gli anticorpi precipitanti sono comparsi nel siero sanguigno dopo 2-3 settimane, ma sono scomparsi prima degli anticorpi neutralizzanti il virus. Anticorpi fissatori del complemento sono stati trovati nel sangue di polli convalescenti.
Coltivazione di virus. Il virus può essere coltivato su embrioni di pollo quando infetti nella cavità allantoidea, amniotica o CAO. I segni della riproduzione del virus nell'embrione di pollo sono l'effetto nanismo (crescita lenta), la mummificazione, la forma sferica dell'embrione e la morte entro 3-6 giorni dall'infezione. Un numero significativo di ceppi virali si moltiplica nella coltura cellulare di embrioni di pollo e BHK-21 con la formazione di CPD.
Non è stato osservato nella maggior parte dei ceppi del virus IB. Il ceppo del Connecticut è in grado di agglutinare i globuli rossi del pollo, mentre il ceppo del Massachusetts mostra tale attività solo dopo trattamento con trypsin o fosfolipasi C.
Esistono tre sindromi cliniche della malattia: respiratoria, nefroso-nefrite e riproduttiva.
La sindrome respiratoria si verifica più spesso nei polli di età inferiore a 1 mese ed è caratterizzata da tosse, respiro sibilante tracheale, secrezione nasale, difficoltà respiratorie, congiuntivite, sinusite e elevata mortalità. Nei polli di 1-2 mesi la malattia si manifesta cronicamente con colibacillosi e micoplasmosi.
La sindrome nefroso-nefrite si osserva nei polli fino a 2 settimane di età quando sono infettati da ceppi nefrotropici del virus. Appare la diarrea e muore fino al 70% dei polli.
La sindrome riproduttiva viene solitamente registrata nei polli di età superiore all'età gestazionale; caratterizzato da una forte diminuzione della produzione di uova e dalla forma irregolare del guscio dell'uovo. Nel 20-25% delle galline ovaiole che hanno avuto IB gioventù, si nota il sottosviluppo dei follicoli delle uova.
All'autopsia, si riscontra essudato sieroso catarrale e caseoso nella trachea e nei bronchi (con sindrome respiratoria), danni ai reni e agli ureteri (con sindrome nefro-nefrite) e sottosviluppo dei follicoli uovo (con sindrome riproduttiva).
Nelle prime due settimane di malattia, il virus viene adsorbito sulle cellule delle mucose delle vie respiratorie e in esse si moltiplica. Lo sviluppo del processo infettivo è accompagnato da viremia con localizzazione del virus nei leucociti e negli eritrociti per diverse settimane dopo l'infezione. Con il sangue, il virus entra nei reni, nei polmoni, nelle ovaie e negli ovidotti, nelle cui cellule si moltiplica e provoca un processo patologico. Può anche essere rilevato nella milza (fino a 49 giorni), nei reni (fino a 35 giorni) e nella cloaca (fino a 45 giorni).
Il virus viene rilasciato con le secrezioni dagli occhi e dal naso, nonché con le feci e nei galli - con lo sperma entro 20 giorni dall'infezione. Il virus viene rilasciato dal contenuto delle uova dei polli malati fino a 6 settimane dopo l'infezione.
La principale fonte di infezione sono i polli e i polli malati e guariti. Gli animali recuperati rimangono portatori del virus e l'allevamento è stato considerato non sicuro per la malattia per diversi anni. Il virus si trasmette per via aerogena, nutrizionale, per contatto diretto e indiretto, nonché per via transovarica .
La diagnosi viene effettuata sulla base di dati epidemiologici, segni clinici della malattia, cambiamenti patologici e ricerca di laboratorio.
Diagnostica di laboratorio. Materiale patologico per studi di laboratorio sono tamponi della laringe, trachea di uccelli malati e raschiature di cadaveri, pezzi di polmoni, reni e di uccelli adulti - reni e ovidotti.
Il rilevamento dell'acido nucleico virale nel materiale patologico viene effettuato mediante PCR. L'antigene del virus può essere rapidamente rilevato nell'RDP e nel RIF. L'uso di anticorpi monoclonali gruppo-specifici o di siero iperimmune nel RIF consente la sierotipizzazione immediata.
Il virus IB attivo viene rilevato mediante un test biologico. È più efficace se effettuato su polli di età compresa tra 10 e 25 giorni provenienti da allevamenti esenti da malattie respiratorie. Una sospensione ottenuta da materiale patologico viene utilizzata per infettare i polli per via intratracheale e dopo 1-5 giorni si osserva la comparsa di sintomi respiratori e alterazioni patologiche caratteristiche dell'IB.
Per eseguire un biotest su embrioni di pollo di 8-10 giorni è necessario effettuare 6-8 passaggi “alla cieca”. Durante il processo di passaggio, l'isolato di campo del virus si adatta agli embrioni di pollo e su di essi iniziano a comparire i cambiamenti patologici tipici dell'IB. La coltura cellulare non viene utilizzata per il test biologico, poiché in essa il virus può causare la CDP solo dopo l'adattamento agli embrioni di pollo.
Identificazione. Il materiale ottenuto come risultato del test biologico contiene un virus che deve essere identificato nell'RDP, RNGA e RIF, e il tipo è determinato nell'RN sugli embrioni di pollo e nell'RTGA.
I test sierologici possono velocizzare la diagnosi.
Sierodiagnosi si basa sulla rilevazione di anticorpi negli uccelli malati e guariti in RN, RNGA ed ELISA. Inoltre, se il pH determina l'accumulo di anticorpi nel corpo durante il periodo dal 10° al 36° giorno di malattia, allora RNGA - dal 2° al 14° giorno, ELISA - dal 3° giorno.
È stato stabilito che i dati sierologici non consentono di giudicare la resistenza di una particolare popolazione di uccelli all'infezione da virus IB, poiché il livello degli anticorpi non è sempre correlato alla resistenza. In quest'ultimo caso, l'immunità tissutale locale della tracheite respiratoria gioca un ruolo importante.
Va tenuto presente che l'IB è simile alla laringotracheite infettiva, alla malattia di Newcastle e all'influenza aviaria. La diagnosi differenziale di queste malattie viene effettuata utilizzando metodi di laboratorio.
L'uccello guarito è resistente all'infezione con un ceppo omologo del virus per 5-6 mesi. La difficoltà di fornire una prevenzione specifica della bronchite infettiva nei polli è dovuta alla grande variabilità antigenica e immunologica dei ceppi virali sul campo.
Sia i vaccini vivi che quelli inattivati vengono utilizzati per prevenire l’infezione. Gli anticorpi materni delle galline ovaiole immuni vengono trasferiti attraverso l'uovo ai pulcini e li proteggono nelle prime 2-4 settimane di vita. La risposta immunitaria più pronunciata è stata ottenuta quando vaccinati a 3-4 settimane di età con un vaccino vivo e a 16 settimane con un vaccino inattivato. Considerando la formazione dell'immunità tissutale locale nelle vie respiratorie, i vaccini vivi vengono somministrati per via orale (con acqua potabile) o mediante instillazione nel naso.
virus dell'afta epizootica
L'afta epizootica è una malattia acuta e altamente contagiosa degli artiodattili, che si manifesta con febbre, lesioni vescicolari delle mucose della bocca, pelle della corolla e delle mammelle e, negli animali giovani, danni al miocardio e ai muscoli scheletrici. L’afta epizootica è registrata in molti paesi del mondo.
In condizioni naturali, gli artiodattili domestici e selvatici sono sensibili al virus dell'afta epizootica. Cani e gatti possono essere infettati e rimanere asintomatici. Una persona raramente viene infettata consumando latte non disinfettato di animali malati.
Resistenza alle influenze fisiche e chimiche. Il virus dell’afta epizootica è resistente all’etere, al cloroformio e al freon. Viene rapidamente inattivato in un ambiente con un pH pari o inferiore a 6,0. Più stabile a pH 7,0-7,5. La calce sbiancata, la creolina, il cresolo, il fenolo uccidono il virus solo dopo poche ore. Le soluzioni alcaline (2%) lo inattivano in 10 minuti. Il virus è resistente ai fattori ambientali; La linfa afta contenente il virus viene inattivata ad una temperatura di 31°C in 24 ore; nel latte ad una temperatura compresa tra 66 e 78°C il virus muore in 1 minuto. Le basse temperature lo preservano: a meno 40 - meno 70°C conserva le sue proprietà biologiche per diversi anni. Il virus sopravvive nelle acque reflue fino a 103 giorni. Un buon conservante è una soluzione al 50% di glicerolo in tampone fosfato; il virus può essere conservato al suo interno a 4-8°C per 40 giorni. I migliori disinfettanti sono soluzioni calde al 2 o 3% di bicarbonato di sodio e soluzione di formaldeide all'1%.
La sospensione contenente virus contiene particelle virali infettive e non infettive: 140S - virioni completi; 5S - capsidi senza RNA; 12S-14S - subunità proteiche e Via-chtigen, che si trova nelle cellule infette, ma non è parte integrante del virione. Tutti questi componenti hanno proprietà antigeniche, ma solo le particelle 140S e 755 sono immunogeniche. Solo le particelle HOS (virioni completi) sono infettive.
Variabilità antigenica.
Attualmente sono noti 7 tipi antigenici del virus dell'afta epizootica: A, O, C, Sat-1, Sat-2, Sat-3 e Asia-1. All'interno dei tipi principali esistono varianti, o sottotipi, che differiscono tra loro. Il tipo A ha 32 opzioni, il tipo O - 11 opzioni, il tipo C - 5, il tipo Sat-1 - 7 opzioni, il tipo Sat-2 - 3 opzioni, il tipo Sat-3 - 4 opzioni e il tipo Asia-1 - 2 opzioni. I tipi antigenici e le varianti identificati nelle RSC differiscono anche dal punto di vista immunologico. Gli animali guariti acquisiscono una pronunciata immunità al virus omologo. Pertanto, per la prevenzione specifica dell'afta epizootica è necessario che esista un vaccino per ciascun tipo di virus.
Nel corpo degli animali naturalmente sensibili, il virus induce la formazione di anticorpi che neutralizzano il virus, fissano il complemento e precipitano.
Il virus viene coltivato su animali naturalmente sensibili e da laboratorio: topi e conigli appena nati, criceti di 60 giorni, porcellini d'India adulti. Si moltiplica bene nella coltura di cellule renali di animali sensibili, nella coltura di espianti dell'epitelio della lingua dei bovini e in alcune linee cellulari continue (BNK-21, SPEV, ecc.) con un pronunciato effetto citopatico.
Infezione sperimentale. Si riproduce facilmente applicando materiale contenente virus sulla superficie scarificata della mucosa della lingua, sulle gengive di bovini, ovini e suini (nel muso), nonché mediante inoculazione sottocutanea del virus in topi o conigli neonati e iniezione intradermica del materiale nella superficie plantare delle zampe posteriori delle cavie.
Il periodo di incubazione dura 1-3 giorni, a volte fino a 7-10 giorni. Il segno più caratteristico di questa malattia negli animali sono le lesioni vescicolari delle mucose della bocca, della pelle della corolla e della mammella. Nei bovini e nei suini l'afta epizootica è acuta; negli animali adulti è generalmente benigna. La malattia si diffonde molto rapidamente. Inizialmente si nota un peggioramento dell'appetito, un aumento della salivazione e un aumento della temperatura corporea (fino a 40,5-41,5 ° C). Il 2-3o giorno, le afte compaiono sulla superficie interna delle labbra e sulla lingua. In alcuni animali si formano afte sulla mammella. La malattia degli arti è accompagnata da zoppia. Dopo un giorno le afte si rompono e si formano delle erosioni. Tra 2-3 settimane. le erosioni guariscono e gli animali si riprendono. Nei suini, nelle pecore e nelle capre le lesioni si osservano più spesso sugli arti e meno spesso sulle mucose della bocca. Abbastanza spesso la mammella è colpita. Negli animali giovani, l'afta epizootica di solito ha un decorso maligno (morte - 80% o più), di regola non c'è poppa.
Patologico i cambiamenti.
Durante l'autopsia di animali giovani morti, si notano infiammazioni emorragiche dell'intestino e cambiamenti degenerativi nei muscoli del cuore (cuore "tigre"); cambiamenti simili si trovano nei muscoli scheletrici.
Localizzazione virus. Negli animali malati il virus può essere rilevato già durante il periodo di incubazione nel latte, nello sperma, nella saliva (4-7 giorni prima dei segni clinici). Quantità più grande Il virus è contenuto nell'epitelio e nel liquido vescicolare (fino a 108ID/g). Gli escrementi e le secrezioni degli animali malati sono contagiosi per più di 10 giorni. Il virus viene rilasciato anche nell'aria espirata. La recidiva può essere accompagnata da un prolungato trasporto virale. Circa il 50% dei bovini può diffondere il virus per 8 mesi e alcuni fino a due anni. Non è stata accertata la permanenza persistente del virus nei suini. Nelle mandrie di bufali, l’infezione è stata mantenuta per molti anni da portatori del virus e da animali con infezione latente.
Fonte di infezione servono animali malati e portatori di virus. Il ruolo epizootologico degli artiodattili selvatici è molto significativo. Il virus è altamente contagioso, quindi la malattia si diffonde rapidamente tra gli animali sensibili. I prodotti e le materie prime di origine animale, nonché gli articoli per la cura, il letame e i mangimi contaminati dalle secrezioni di bestiame malato, svolgono un ruolo importante nella diffusione dell'afta epizootica. Anche gli animali immuni all’afta epizootica (cani, gatti, cavalli e uccelli) possono essere portatori dell’infezione.
La diagnosi di afta epizootica viene posta sulla base di dati epizootologici (elevata contagiosità e danno selettivo solo agli artiodattili), segni clinici (danni vescicolari alle mucose della bocca, pelle, arti e mammelle), alterazioni patologiche (in caso di morte di animali giovani - danni all'intestino e ai muscoli cardiaci) e ricerca sui risultati di laboratorio.
È abbastanza semplice diagnosticare l'afta epizootica in base ai segni clinici, ma è importante che il medico aziendale sappia quale tipo di virus CAUSA la malattia per poter utilizzare il vaccino appropriato. Il tipo di virus viene determinato in laboratorio.
Prelievo e preparazione del materiale. Per gli studi di laboratorio si prelevano da 2-3 animali malati almeno 5 g della parete e del contenuto delle afte sulla mucosa della lingua (nei bovini), sul muso (nei suini), sulla pelle della corolla e fessura interdigitale (nei bovini e nei piccoli ruminanti), suini, cammelli, ecc.). In assenza di afte, il sangue degli animali viene prelevato al momento della reazione termica, dai cadaveri di animali giovani di tutti i tipi: dai linfonodi della testa e dall'anello retrofaringeo, dal pancreas e dal muscolo cardiaco. Per verificare la presenza di virus viene prelevato il muco esofagofaringeo (con una sonda speciale).
Il materiale deve essere ottenuto in modo tale da prevenire la diffusione del virus al di fuori del focolaio e del laboratorio a rischio e da proteggere il personale che lavora con materiale infetto.
Per questo:
a) il veterinario aziendale deve possedere determinate competenze nel prelievo di materiale da animali malati;
b) è necessario preparare tutto per il campionamento del materiale: pinzette, forbici, tovaglioli, bottiglie a pareti spesse, nastro adesivo, tappi di gomma, una soluzione al 50% di glicerina sterile in una soluzione isotonica di cloruro di sodio, un thermos con una miscela rinfrescante , una soluzione disinfettante - soluzione di NaOH al 2% o soluzione all'1% di acido acetico o lattico; indumenti da lavoro: camici, tute, sciarpe o cappelli, maschere, stivali di gomma, guanti, ecc. Tutto il necessario viene messo in un contenitore e si recano in un focolaio travagliato, dove, prima di entrare in una stanza con animali malati, si cambiano d'abito; c) dopo aver prelevato materiale da animali malati, gli strumenti, la maschera, i guanti vengono immersi in una soluzione disinfettante; La superficie esterna delle bottiglie e del thermos viene trattata con una soluzione disinfettante. Nella sala di ispezione sanitaria si tolgono tutti i vestiti e fanno la doccia.
Nell'uomo, il virus dell'afta epizootica sopravvive nella cavità nasale fino a 7 giorni, pertanto, durante questo periodo, dopo aver visitato una fattoria disfunzionale, il contatto con animali artiodattili sani è indesiderabile.
I campioni di materiale senza segni di decomposizione vengono posti in bottiglie con tappi avvitati o smerigliati e congelati e, in assenza di condizioni di congelamento, riempiti con un liquido conservante (soluzione sterile al 50% di glicerolo in una soluzione isotonica di NaCl ). Sulle bottiglie vengono poste etichette indicanti la tipologia di animale, il nome del materiale, la sua quantità, la data di selezione e l'indirizzo del mittente. Le bottiglie vengono poste in un contenitore metallico impenetrabile, sigillato e posto in un thermos con ghiaccio, anch'esso sigillato. Al materiale è allegata una lettera di accompagnamento firmata da un medico, nella quale sono indicati: la data di prelievo del materiale, da quali specie di animali e quale materiale è stato prelevato, la situazione epizootica relativa all'afta epizootica nell'azienda agricola, e la situazione nome del medico. Il materiale viene inviato tramite corriere espresso. Per lavorare con il virus dell'afta epizootica in laboratorio, viene assegnata una stanza separata (una scatola con una pre-scatola), dove dovrebbe esserci equipaggiamento necessario e materiali per lo svolgimento del lavoro diagnostico (preparazione del materiale, stadiazione di RSK, test biologici, ecc.). Quando lavorano nella boxe, cambiano completamente tuta e scarpe, indossano guanti di gomma e una maschera. Dopo il lavoro non si può togliere dalla scatola nulla che non sia stato reso innocuo. Piatti e strumenti vengono bolliti, gli indumenti protettivi vengono immersi in un contenitore per l'autoclavaggio; tavoli, pavimenti, pareti vengono trattati con soluzione disinfettante seguita da irradiazione con raggi UV.
Il laboratorio tiene registri rigorosi del materiale in entrata e del suo consumo con una precisione di 1 mg. Il materiale ricevuto dal laboratorio viene conservato prima dell'esame e durante l'uso in un frigorifero chiuso a chiave e sigillato. Alla fine del lavoro viene redatto un atto per la distruzione del materiale rimasto dallo studio e dagli animali dopo il test biologico.
I test di laboratorio per l’afta epizootica includono:
Rilevazione e identificazione dell'antigene del virus dell'afta epizootica nella RSC (determinazione del suo tipo e variante);
Rilevazione e titolazione degli anticorpi contro il virus dell'afta epizootica negli animali guariti (convalescenti) nella reazione di immunodiffusione radiale (RRID) e nella reazione di immunofluorescenza indiretta (IRIF).
Rilevazione e identificazione dell'antigene del virus dell'afta epizootica mediante RSC. Componenti della reazione: testare gli antigeni di ceppi epizootici del virus di animali malati; siero di cavie iperimmunizzate con ceppi standard tipici e varianti del virus dell'afta epizootica (produzione in biofabbrica); antigeni di controllo - da ceppi standard e varianti del virus dell'afta epizootica (produzione in biofabbrica); complemento: siero normale fresco o secco di cavia; emolisina biofabbricata; globuli rossi di pecora - sotto forma di sospensione al 2% in soluzione fisiologica; Soluzione allo 0,85% di cloruro di sodio chimicamente puro in acqua distillata; un insieme di sieri e antigeni specifici per altri virus che causano lesioni vescicolari.
RSC viene posto in diversi volumi: in un volume totale di 1 ml - prelevare 0,2 ml di ciascun componente, in un volume totale di 0,5 ml - prelevare 0,1 ml di ciascun componente, o utilizzando il micrometodo - un volume totale di 0,125 ml, con ciascun componente pari a 0,025 ml.
Preparazione dell'antigene del virus dell'afta epizootica .
Le pareti delle afte di animali malati vengono lavate dal liquido conservante con soluzione fisiologica pH 7,4-7,6, asciugate con carta da filtro, pesate, frantumate e macinate accuratamente in un mortaio di porcellana con vetro neutro rotto sterile fino ad ottenere una massa omogenea, alla quale viene aggiunto il doppio della massa della poppa è la quantità di soluzione salina, cioè per 1 g di poppa -2 ml di soluzione. La sospensione risultante al 33% viene estratta a temperatura ambiente 2 ore, a meno 10-20C per 5-18 ore Dopo lo scongelamento, centrifugare per 15-30 minuti a 3000-5000 min-1. Il surnatante viene inattivato a 58°C per 40 minuti. Dopo l'inattivazione, se rimangono scaglie nel liquido, centrifugarlo nuovamente per 10-15 minuti a 3000 min-1 e quindi utilizzarlo come antigene in RSC.
Fasi produzioni RSK.
Titolazione dell'emolisina. Effettuare quando si riceve una nuova serie secondo i metodi generalmente accettati. Nell'esperimento principale l'emolisina viene assunta in una concentrazione pari a 4 volte il suo titolo limite (diluizione di lavoro).
Preparazione del sistema emolitico (sistema eme). Per fare ciò, mescolare l'emolisina in una diluizione di lavoro con una quantità uguale di una sospensione al 2% di eritrociti di pecora.
Titolazione del complemento. Condotto nel sistema emolitico il giorno dell'esperimento principale secondo il metodo generalmente accettato. Per l'esperimento RSC principale, il complemento viene assunto con un eccesso dell'1% del suo titolo nel sistema eme. Una dose operativa di complemento assunta correttamente è una condizione indispensabile per il normale decorso della reazione, che garantisce l'affidabilità dei risultati.
Preparazione di diluizioni di lavoro di sieri tipo-specifici. Nell'esperimento principale per determinare il tipo di virus dell'afta epizootica, il siero viene utilizzato a doppio titolo (dal titolo limite), ad esempio, se il titolo limite del siero è 1:40, il titolo di lavoro sarà 1 :20.
Preparazione di una diluizione operativa di antigeni tipo-specifici. Gli antigeni vengono utilizzati anche nei titoli doppi, ad esempio, se il titolo limitante è 1:6, il titolo di lavoro sarà 1:3.
L'antigene del test nella reazione viene esaminato intero (sospensione al 33%) e in diluizioni 1:2, 1:4 e 1:8.
Nota. Secondo i risultati presentati, tutti gli antigeni e i sieri standard sono attivi e tipo-specifici. L'antigene testato è di tipo A.
La reazione viene registrata 5-10 minuti dopo il bagnomaria e il risultato finale si ottiene dopo 10-12 ore.Il grado di ritardo dell'emolisi viene valutato mediante croci: (++++) - 100% ritardo dell'emolisi; (+++) - 75%; (++) - 50%; (+) - Ritardo del 25% nell'emolisi; (-) - emolisi completa.
Se l'antigene del test è omologo ad anticorpi specifici, si verificherà un ritardo nell'emolisi e la reazione sarà positiva; se gli anticorpi omologhi sono assenti la reazione è negativa e si osserva emolisi completa.
Se necessario, dopo aver determinato il tipo di virus dell'afta epizootica, viene determinato il suo sottotipo (variante). Per fare ciò, la RSC viene eseguita utilizzando lo stesso metodo, ma vengono utilizzati sieri varianti e antigeni varianti del tipo stabilito. Inoltre, si utilizzano sieri varianti a titolo massimo e antigeni a titolo doppio. L'antigene (testato) viene assegnato alla variante con il siero di cui dà una reazione positiva in diluizioni più elevate.
Quando il materiale virale consegnato dall'allevamento non è sufficiente per la ricerca presso il RSC, viene propagato su colture cellulari o su topi lattanti di 3-6 giorni di età, o su cavie adulte. Nei topi, la sospensione di prova viene somministrata per via sottocutanea nella zona dorsale alla dose di 0,1-0,2 ml, nelle cavie - per via intradermica nei cuscinetti di entrambi gli arti posteriori alla dose di 0,2-0,5 ml. Gli animali vengono osservati per 5-7 giorni.
In caso di morte dei topi, dalle loro carcasse viene preparato un antigene per la RSC. Nei casi positivi, le cavie sviluppano afte sulle zampe; le pareti di poppa e il loro contenuto sono utilizzati in RSC. Se necessario si effettuano 2-3 passaggi “alla cieca”. Un campione del materiale di prova è considerato negativo se nel terzo passaggio non si nota degenerazione cellulare e morte dei topi bianchi e, durante l'esame delle sospensioni ottenute da essi, l'antigene del virus dell'afta epizootica non viene rilevato nell'RSC.
Diagnosi retrospettiva.
Il materiale per testare la presenza di anticorpi contro il virus dell'afta epizootica è il siero sanguigno di animali sospettati di avere l'afta epizootica o altre malattie vescicolari. Il siero del sangue deve essere prelevato non prima di 7 giorni dal momento in cui compaiono i segni della malattia vescicolare negli animali. Inviare per il test 5-10 campioni di siero di animali di ciascuna fascia di età. Se i risultati dello studio iniziale sono dubbi, è necessario prelevare nuovamente il sangue dagli stessi animali dopo 7 - 10 giorni.
Il siero ottenuto con il metodo standard viene conservato con antibiotici (500 unità/ml di penicillina e streptomicina) o congelato a meno 20°C. Almeno 5 ml di siero di ciascun animale vengono inviati per il test in un thermos con ghiaccio.
In laboratorio, il siero viene esaminato utilizzando la reazione di immunodiffusione radiale (RRID) e la reazione di immunofluorescenza indiretta (IRIF).
RRID. L'essenza della reazione è la formazione di una zona di precipitazione specifica di antigeni virali da parte di anticorpi inclusi nel gel di agar. L'RRID è specifico del tipo.
Per impostare la reazione, l'agar fuso al 2% viene miscelato con un volume uguale di siero da testare riscaldato a 50-55°C in diluizioni di 1:5, 1:10, 1:20, ecc. fino a 1: 320 e applicare 4 ml su un vetrino. I pozzetti (4-7,7 mm di diametro) vengono tagliati dall'agar solidificato e riempiti con antigeni standard standard. I bicchieri vengono poi posti in una camera umida alla temperatura di 37°C. I risultati vengono presi in considerazione dopo 6-7 ore e infine dopo 18 ore.
Una reazione positiva è caratterizzata dalla formazione di un anello di precipitazione sotto forma di zona opalescente attorno al foro con un antigene omologo all'agente patogeno che ha causato la malattia.
Gli anticorpi rilevati nel campione di siero in esame vengono assegnati al sierotipo con l'antigene con cui hanno dato una reazione positiva. Il loro titolo è considerato la diluizione massima del siero in esame con il quale si osserva una reazione positiva.
Dopo che gli animali si sono ripresi dalla malattia, i titoli anticorpali solitamente superano 1:160.
NRIF. Questa reazione si basa sul fatto che la presenza di anticorpi nel siero sanguigno degli animali recuperati rivela una luminosità specifica (del complesso antigene + anticorpo) e quando si utilizzano sieri di animali vaccinati, la luminosità del complesso non viene osservata.
La tecnica di impostazione è la seguente. Il siero in esame viene applicato ad un preparato proveniente da una coltura di cellule BHK-21, PEC, PES infettate da qualsiasi tipo di virus dell'afta epizootica ad una diluizione di 1:10 e 1:20; incubare in camera umida a 37°C per 30 minuti; lavare gli anticorpi non legati; essiccati all'aria e colorati con una miscela di diluizioni di lavoro di siero anti-specie fluorescente e albumina bovina marcata con rodamina; Incubare in camera umida a 37°C per 30 minuti; lavato; essiccati e osservati al microscopio a fluorescenza (lente x40, oculare x4 o x5). Una reazione positiva è caratterizzata da un bagliore verde o verde minerale nel citoplasma delle cellule.
Il risultato diagnostico è considerato positivo quando viene rilevato uno specifico bagliore in almeno uno dei 5-10 sieri inviati da un determinato allevamento.
Per determinare il livello di anticorpi rilevati in questo modo nel siero in esame, questo viene titolato. Per fare ciò, il siero in esame viene diluito da 1: 40 a 1: 1280, e con ciascuna diluizione viene trattato un farmaco noto infetto, come sopra indicato. Il titolo degli anticorpi post-infettivi nel siero viene giudicato dalla sua diluizione massima, che può dare un NRIF positivo. La presenza di una lucentezza specifica nelle preparazioni trattate con il siero in esame in diluizioni 1:10, 1:20 e 1:40 indica che il siero è stato ottenuto durante il periodo di malattia acuta dell'animale affetto da afta epizootica, vale a dire Sono trascorsi circa 7 giorni dalla sua malattia e la presenza di uno specifico bagliore in diluizioni di 1:80 e superiori indica che il siero è stato prelevato da un animale convalescente.
I risultati dello studio sull'afta epizootica vengono redatti sotto forma di protocollo, nel quale sono indicati la data dello studio, il nome dell'azienda agricola, il materiale, brevi dati epizootologici, ecc. e sono richiesti il nome dei componenti utilizzati nello studio e le caratteristiche dei controlli.
Va notato che sono stati sviluppati molti altri metodi per l'indicazione e la tipizzazione del virus dell'afta epizootica, come PCR, RNGA, ELISA, metodo dell'immunità crociata, ecc.; per il rilevamento e la tipizzazione degli anticorpi - RN, RNGA, reazione di sieroprotezione nei topi allattati, ecc.
Diagnosi differenziale.È necessario escludere altre malattie degli animali con sindrome vescicolare, come malattie veneree, IRT, stomatite vescicolare, nei suini - malattia vescicolare, esantema vescicolare, nelle pecore - febbre catarrale degli ovini.
Immunità e prevenzione specifica.
La durata dell'immunità negli animali guariti dall'afta epizootica è di 8-12 mesi, nei suini - 10-12, nelle pecore - 18 mesi. Con un'immunità molto tesa si può osservare una certa resistenza all'infezione da parte di un tipo di virus eterologo. Con l'afta epizootica si verifica l'immunità tissutale e umorale. I fattori dell’immunità umorale svolgono un ruolo importante nella protezione degli animali dalle malattie. Per la prevenzione specifica dell'afta epizootica vengono utilizzati vaccini inattivati. I seguenti 3 vaccini hanno trovato un uso diffuso nel nostro Paese: il vaccino con saponinformolo a base di idrossido di alluminio lapinizzato, che viene preparato da un virus riprodotto nel corpo di conigli neonati; vaccino con saponinformolo idrossido di alluminio ottenuto da un virus coltivato nel tessuto della mucosa della lingua.
Per i suini viene utilizzato un vaccino emulsionato a base di virus lapinizzato.
L'immunità dopo la vaccinazione negli animali adulti dura 4-6 mesi. Dopo la rivaccinazione, l'immunità è più forte e più duratura.
Gli animali giovani nati da animali immuni ricevono passivamente gli anticorpi attraverso il colostro. Gli anticorpi nei vitelli persistono per 5 mesi, sebbene la protezione passiva duri fino a 3-4 mesi.
I vaccini inattivati possono essere mono o polivalenti, cioè contengono antigeni di uno o più tipi e varianti del virus. Non sono stati sviluppati vaccini vivi contro l’afta epizootica. Sono in corso ricerche sullo sviluppo e l'uso di vaccini sintetici, nonché di vaccini molecolari ottenuti mediante metodi di ingegneria genetica.
CultiviroCrescita del virus in colture cellulari
Le colture cellulari e tissutali sono pezzi di organi e tessuti cresciuti in un mezzo nutritivo esterno al corpo che rimangono vitali e alcuni si riproducono.
Per coltivazione richiesta:
Materiale di partenza (tessuto embrionale, rene, pelle, cellule della milza). Il rispetto delle regole di asepsi e antisettici è obbligatorio;
La temperatura dovrebbe essere di 36 -38 gradi Celsius;
Un mezzo nutritivo che deve essere tamponato e isotonico, cioè includono Na, K, Ca, Mg, Cl, fosfati, carbonati;
Il pH del terreno dovrebbe essere compreso tra 7,2 e 7,4 unità;
Tutti i nutrienti, in particolare il glucosio, responsabile del metabolismo energetico;
Aminoacidi;
Vitamine che sono coenzimi.
Esistono due tipi di media:
1. naturale o naturale (sangue, liquido amniotico);
2. sintetico e semisintetico (da prodotti chimici, soluzioni saline - soluzione di Earle e soluzione di Hanks)
Metodologia si riduce a questo:
1. selezione della coltura cellulare;
2. ricevere materiale contenente virus;
3. preparazione all'infezione;
4. infezione di cellule con materiale contenente virus;
5. coltivare il virus nelle cellule;
6. indicazione del virus in coltura cellulare;
7. raccolta del fluido di coltura e identificazione del virus in esso contenuto.
Selezione delle colture cellulari. Non tutte le cellule sono sensibili a tutti i virus. Il virus di solito si adatta con successo alla coltura primaria, a condizione che la coltura sia ottenuta dagli organi di un animale naturalmente suscettibile al virus. Tuttavia, l’adattamento del virus alle cellule trapiantabili è più complesso e, in alcuni casi, impossibile. Non è ancora noto alcun sistema cellulare in grado di coltivare alcuni virus. Per coltivare il virus vengono solitamente utilizzate cellule giovani, ad es. il primo giorno di formazione del monostrato e in alcuni casi (per i parvovirus suini) le cellule vengono infettate quando vengono inoculate, poiché il virus si moltiplica intensamente in presenza di cellule in divisione (quando sono nella fase di crescita logaritmica).
Infezione cellulare.
Per fare questo vengono selezionate provette (o materassi) con un monostrato di cellule continue, osservandole al microscopio a basso ingrandimento. Il mezzo di crescita viene drenato, le cellule vengono lavate 1-2 volte con la soluzione di Hanks per rimuovere gli anticorpi e gli inibitori sierici. A ciascuna provetta vengono aggiunti 0,1-0,2 ml di materiale contenente virus e distribuiti uniformemente sullo strato cellulare mediante agitazione. In questa forma, le provette (materassini) vengono lasciate per 1 o 2 ore a 22 o 37 C affinché il virus venga adsorbito sulla superficie cellulare. Quindi il materiale contenente il virus viene rimosso dalle provette (materassi) e viene versato il mezzo di supporto (1-2 ml nella provetta, circa il 10% del suo volume nei materassi). Quando si isola il virus da materiale patologico, alcuni campioni (feci, ecc.) possono avere un effetto tossico sulle cellule, pertanto, dopo l'assorbimento del virus, il monostrato cellulare viene lavato 1-2 volte con la soluzione di Hanks (o mezzo nutritivo) e quindi viene versato il mezzo di supporto.
Coltivazione di virus.
Le provette (materassini) vengono sigillate con tappi di gomma e poste per l'incubazione in un termostato a 37°C. L’incubazione stazionaria è quella più utilizzata. In questo caso i materassi vengono posti in posizione orizzontale, le provette vengono posizionate con un angolo di 5° in modo che il monostrato di cellule si trovi sotto il mezzo nutritivo (allineate). In numerosi laboratori, le colture cellulari infette vengono incubate su un sistema rotante chiamato rulli. Utilizzando questo metodo è possibile ottenere una grande resa di virus con un titolo infettivo più elevato rispetto alla coltivazione stazionaria.
Per ogni campione di materiale vengono solitamente utilizzate almeno 4-10 provette per colture cellulari. Per il controllo vengono lasciate 4-6 provette con una coltura cellulare non infetta, in cui il mezzo di crescita viene sostituito con uno di supporto.
Nelle colture cellulari infette da un virus, il mezzo nutritivo non può essere cambiato per 7 giorni e il pH del mezzo (6,9-7,4) può essere mantenuto utilizzando una soluzione di bicarbonato di sodio al 7,5%. Con una coltivazione più lunga di cellule infette (adenovirus, ecc.), il terreno viene modificato.
Dopo l'infezione delle cellule, tutte le provette (materassi) vengono esaminate quotidianamente al microscopio a basso ingrandimento, confrontando le colture cellulari infette dal virus con quelle di controllo.
Nel termostato, le particelle virali adsorbite sulle cellule penetrano in esse e inizia la loro riproduzione. Nuove particelle virali lasciano (in tutto o in parte) le cellule in cui si sono formate, penetrano nelle cellule non colpite, si riproducono in esse, si spostano in nuove cellule e le infettano. Ciò continua finché ci sono cellule vive e non danneggiate. Come risultato di questo processo, quasi tutte le cellule del materasso o della provetta vengono colpite dal virus, anche se assolutamente tutte non vengono quasi mai colpite.
Il virus si accumula principalmente nel liquido di coltura, ma alcuni virioni possono rimanere all'interno delle cellule non distrutte dal virus. Per rilasciare il virus rimasto nelle cellule, le cellule vengono accuratamente distrutte mediante ripetuti congelamenti e scongelamenti (2-3 volte) o mediante ultrasuoni.
Indicazione (rilevamento) del virus nella coltura cellulare.
Esistono i seguenti metodi principali per indicare il virus in coltura cellulare: per effetto citopatico o azione citopatica (CPE, CPE); da una reazione positiva di emoassorbimento (RHAd); dalla formazione di placche; per il rilevamento di inclusioni intracellulari; per identificare i virus nella reazione di immunofluorescenza (RIF); rilevare l'interferenza dei virus; per sopprimere il metabolismo cellulare (test del colore); microscopia elettronica, ecc.
Nella maggior parte dei casi e spesso, la riproduzione di un virus in una coltura cellulare viene giudicata in base all'effetto citopatico o all'effetto citopatico. La CPD si riferisce a qualsiasi cambiamento nelle cellule sotto l'influenza di un virus che si moltiplica nella coltura cellulare. I cambiamenti fisiologici nelle cellule sono abbastanza difficili da stabilire, ma i cambiamenti morfologici vengono rilevati abbastanza facilmente. Per fare ciò, è sufficiente posizionare una provetta o un materasso sul tavolino del microscopio con uno strato di cellule rivolto verso l'alto ed esaminare lo strato con un ingrandimento basso (lente x8-10, oculare x7-10). È utile confrontare le cellule infettate da un virus con le stesse cellule in una provetta che non sono state infettate. In questo caso, quasi tutte le differenze tra la coltura cellulare infetta e il controllo osservate al microscopio possono essere considerate una manifestazione di CPD. Queste differenze possono coprire l'intero monostrato o essere osservate solo sotto forma di piccoli focolai di cellule alterate nello strato di cellule normali. L'intensità del CPE è espressa da quale parte del monostrato cellulare viene modificata dal virus. Sebbene non esista un sistema generalmente accettato per valutare l’intensità del CPP, spesso viene valutata tramite croci o punti. Quindi, se l'intero monostrato in una provetta o in un materasso ha subito una modifica (rispetto al controllo), il CPP viene valutato con quattro croci, se 3/4 - con 3 croci, se 1/2 - con 2 croci, 1 /4 - con una croce. Ma queste stime sono ancora molto condizionate.
Le forme di CPE dipendono dalle proprietà biologiche del virus, dal tipo di cellula, dalla dose di infezione, dalle condizioni di coltivazione, ecc. Alcuni virus mostrano CPE dopo 2-3 giorni. dopo l'infezione (enterovirus), altri - dopo 1-2 settimane. (adenovirus).
Frammentazione- distruzione delle cellule in frammenti separati, che vengono separati dal vetro e passano nel liquido di coltura sotto forma di detriti cellulari (virus della stomatite vescicolare).
Arrotondamento- perdita della capacità delle cellule di attaccarsi al vetro, per cui le cellule, solitamente sparse sul vetro, assumono una forma sferica, si separano dal vetro e galleggiano liberamente nel liquido di coltura, dove muoiono ( enterovirus, adenovirus, ecc.).
Formazione di simplasti- dissoluzione delle membrane cellulari, a seguito della quale i citoplasmi delle cellule vicine si uniscono, formando un unico insieme in cui si trovano i nuclei cellulari (principalmente lungo la periferia). Tali formazioni di una massa citoplasmatica con molti nuclei cellulari sono chiamate simplasti (cellule multinucleate giganti). La loro formazione è spiegata in due modi: dall'interruzione del processo di divisione cellulare sotto l'influenza di un virus o dal fatto che alcuni virus contengono un enzima (lecitinasi) che dissolve le membrane cellulari, a seguito della quale il citoplasma delle cellule adiacenti si fonde. La maggior parte dei virus può causare CPD nelle colture cellulari; pertanto, questo metodo per indicare i virus nelle colture cellulari è ampiamente utilizzato. Tuttavia, esistono virus che, moltiplicandosi in colture cellulari, non causano la CPD (virus della rabbia, peste suina classica, alcuni ceppi del virus della diarrea bovina, ecc.). Le cellule rimangono vitali, ma l’intensità della divisione cellulare diminuisce e la loro morfologia cambia nel tempo.
Durante la trasformazione neoplastica delle cellule colpite in un monostrato si formano densi focolai di trasformazione di varie dimensioni e forme, bianco(Virus del sarcoma di Rouse).
L'assenza di CPE nel primo passaggio non indica ancora l'assenza di un virus, che non sempre si moltiplica abbastanza velocemente da causare CPE pronunciato. Ecco perché ricorrono a passaggi “ciechi”. È necessario effettuare almeno tre passaggi “alla cieca” prima di giudicare la presenza del virus nel materiale in esame.
Bibliografia.
1. R.V. Belousova, E.A. Preobrazenskij, I.V. Tretyakov “Virologia veterinaria” - M.: KolosS, 2007.
2. V.N. Syurin, R.V. Belousova, I.V. Fomina “Virologia veterinaria” - M.: VO “Agropromizdat”, 1991.
3. R.V. Belousova, N.I. Trotsenko, E.A. Preobrazhenskaya “Workshop sulla virologia veterinaria” - M.: KolosS, 2006.












































 Indietro avanti
Indietro avanti
Attenzione! Le anteprime delle diapositive sono solo a scopo informativo e potrebbero non rappresentare tutte le funzionalità della presentazione. Se sei interessato a quest'opera, scarica la versione completa.
Obiettivi della lezione:
Educativo:
- Sviluppare capacità di apprendimento personali attraverso la formazione dei concetti di “virus”, “virione”, “malattie virali”, “virologia”, ampliando la conoscenza degli studenti Suvorov sulle malattie virali delle piante, degli animali e dell'uomo. Mostrare il pericolo delle malattie virali, giustificare la necessità di conoscere le malattie virali per prevenirle, il ruolo della scienza virologica nella lotta contro le malattie virali.
- Sviluppare capacità educative normative e cognitive attraverso la capacità di gestire attività cognitive ed educative attraverso la formulazione indipendente di un problema e modi per risolverlo, strutturando il materiale studiato, lavorando con letteratura aggiuntiva, la capacità di fare presentazioni, porre domande e condurre opposizione.
- Sviluppare abilità comunicative che offrono opportunità di cooperazione: la capacità di ascoltare, ascoltare e comprendere un partner, controllare le azioni reciproche, esprimere correttamente i propri pensieri nel discorso, rispettare il partner e se stessi nella comunicazione e nella cooperazione.
Obiettivi metodologici: mostrare tecniche metodologiche per sviluppare la cittadinanza tra gli studenti in una conferenza di biologia.
Supporto materiale per la lezione: presentazione, IAD, dispense, messaggi degli studenti Suvorov.
Formato della lezione: conferenza di lezione.
Durante le lezioni
I. Momento organizzativo (30 sec). Saluto, verifica della disponibilità per la lezione, atteggiamento positivo nei confronti del lavoro.
II. Attivare la conoscenza degli studenti(3 minuti).
Agli studenti viene chiesto di rispondere alle seguenti domande (diapositiva 2):
Quali sono le caratteristiche dei virus?
Come funzionano i virus nelle cellule?
III. Fase di orientamento motivazionale(4 minuti).
Hai mai pensato che l'umanità sia stata minacciata da seri nemici fin dall'inizio della sua esistenza? Sono apparsi inaspettatamente, insidiosamente, senza armi tintinnanti. I nemici colpivano senza fallo e spesso seminavano morte. Le loro vittime furono milioni di persone morte di vaiolo, influenza, encefalite, morbillo, SARS, AIDS e altre malattie. Ad esempio, molti personaggi famosi sono morti di AIDS: il grande ballerino Rudolf Nureyev, il famoso scrittore di fantascienza americano Isaac Asimov, l'attore Anthony Perkins, il famoso tennista Arthur Ashe e molti altri (diapositiva 3).
Uno di gente famosa 20th Century, morto di AIDS, era il cantante del gruppo Queen. (Messaggio dei Suvoroviti, diapositive n. 4 – 8, Appendice 1).
Perché, nonostante la medicina abbia raggiunto grandi traguardi, le epidemie influenzali rendono inabili milioni di persone e non esistono farmaci contro l'AIDS? Quale domanda problematica può essere posta? (Risposte degli studenti).
Domanda problematica:“Come evitare le malattie virali? Cosa bisogna sapere per resistere ai virus?
Immagina te stesso come quelle persone che devono proteggere l'umanità dai virus? Di quali conoscenze sui virus hai bisogno per completare questa importante missione? Quale obiettivo ti poni durante la lezione?
Bersaglio: scoprire i pericoli, i metodi di infezione da malattie virali di piante, animali e esseri umani e le misure per la loro prevenzione.
La classe è divisa in tre gruppi, ai quali vengono assegnati dei compiti da discutere alla fine della lezione. (diapositive n. 9 – 10).
Compiti di gruppo: Sulla base del materiale discusso in classe sulle malattie virali, commenta le affermazioni che hai ricevuto:
- “I virus sono una brutta notizia in un buon imballaggio proteico”.
- “I virus si autoproclamano dittatori e motori dell’evoluzione”.
- “La vita è come una scatola di fiammiferi. Trattarlo con leggerezza è pericoloso”.
Dopo aver completato il lavoro, i gruppi si preparano per lo spettacolo. La presentazione di ciascun gruppo si conclude con la formulazione di una conclusione sulla questione considerata e la sua registrazione sui quaderni degli studenti.
Viene ascoltato un relatore di ciascun gruppo.
IV. Imparare nuovo materiale(25 minuti).
Malattie virali delle piante e dei batteri
(Messaggi dei Suvoroviti, diapositive n. 11 - 15).
Nelle piante, i virus provocano mosaici o altri cambiamenti nel colore delle foglie o dei fiori, arricciatura delle foglie e altri cambiamenti nella forma, nanismo; per i batteri: il loro decadimento (Appendice 2).
Malattie virali degli animali
(Messaggi dei Suvoroviti, diapositive n. 16 – 17, Appendice 2).
Negli animali, i virus causano la peste, la rabbia, l’afta epizootica e altri.
Malattie virali umane
Nell'uomo, i virus causano malattie come vaiolo, morbillo, paratite, influenza, ARVI, rosolia, herpes, epatite, AIDS e altri. (Messaggi dei Suvoroviti, diapositive n. 18 – 26, Appendice 2).
L’AIDS è la piaga del 21° secolo. (Messaggi dei Suvoroviti, diapositive n. 27 – 34).
Problema: “Come prevenire l’epidemia di AIDS in Russia?”
Come è iniziato tutto?
L'inizio della storia dell'AIDS nel 1978 è arbitrario, poiché alcuni scienziati ritengono che l'HIV sia passato dalle scimmie all'uomo tra il 1926 e il 1946. Inoltre, ricerche recenti suggeriscono che questo virus potrebbe essere apparso per la prima volta nella popolazione umana già nel XVII secolo, ma si è affermato come ceppo epidemico in Africa solo negli anni ’30. Il campione di sangue umano più antico del mondo contenente l'HIV risale al 1959, l'anno in cui un paziente africano del Congo a cui fu prelevato il sangue morì di AIDS.
Nel nostro paese, la storia dell'AIDS inizia nel 1987 e il suo sviluppo inizialmente non faceva presagire nulla di inquietante. Al 1 luglio 1997, l'infezione da HIV era stata riscontrata in 4830 persone, di cui a 259 era stata diagnosticata l'AIDS.
L’AIDS è stato ufficialmente registrato per la prima volta dal Centro nazionale statunitense per il controllo delle malattie infettive il 5 giugno 1981.
Secondo l’OMS alla fine del 2000:
morirono 22 milioni di persone;
I contagiati sono oltre 36 milioni.
- Nel 2003, circa 40 milioni di persone nel mondo erano infette dal virus HIV.
- Negli ultimi 2 anni, 15 milioni di persone sono state infettate dal virus HIV.
- Più di 24 milioni sono già morti a causa dell’infezione da HIV.
- Ogni giorno più di 16.000 persone vengono infettate dal virus HIV, di cui 7.000 sono giovani di età compresa tra 10 e 24 anni.
Ecco la tabella “AIDS. Non puoi vederlo, ma è nelle vicinanze.
| Cos’è l’HIV e l’AIDS? | L’HIV è il virus dell’immunodeficienza umana. Distrugge il sistema protettivo (immunitario), rendendo una persona incapace di resistere alle infezioni. Le persone infette dall’HIV sono chiamate “infette da HIV”. L'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) è una malattia infettiva virale causata dall'infezione da HIV. Una persona infetta (portatrice dell'HIV) non sviluppa immediatamente l'AIDS; entro 3-10 anni appare e si sente sana, ma può diffondere involontariamente l'infezione. L'AIDS si sviluppa più rapidamente nei portatori di HIV la cui salute è indebolita dal fumo, dall'alcol, dalle droghe, dallo stress e dalla cattiva alimentazione. |
| Come si può rilevare l'HIV? | Esiste un test per gli anticorpi dell'HIV. Dalla presenza di anticorpi nel sangue prelevato da una vena, si determina se c'è stato o meno un contatto con il virus. Va tenuto presente che possono trascorrere diversi mesi dal momento dell'infezione fino alla reazione dell'organismo (il test sarà negativo, ma la persona infetta può già trasmettere l'HIV ad altri). |
| Dove posso sostenere il test? | In qualsiasi centro per l'AIDS nella tua zona. In apposite aule d'esame anonime, dove tutti possono sostenere il test e ottenere il risultato in modo anonimo. |
| Come si infetta l'HIV? | Il virus si trasmette solo attraverso alcuni fluidi corporei. Questo: Secrezione vaginale; Latte materno. Cioè, il virus può essere trasmesso solo: Qualsiasi contatto sessuale penetrativo senza preservativo; In caso di contatto diretto con il sangue attraverso ferite, ulcere, mucose; Quando si utilizzano siringhe non sterili sia per scopi medici che per la somministrazione di farmaci; Di madre in figlio dentro tempo di gravidanza, il parto o l'allattamento al seno. |
| L'HIV non viene trasmesso | -durante i contatti quotidiani (baci, strette di mano, abbracci, condivisione di piatti comuni, piscina, toilette, letto); Attraverso morsi di insetti e animali; Durante la raccolta del sangue del donatore, poiché ciò comporta l'uso di strumenti, siringhe e aghi monouso. |
La via di trasmissione dell’HIV da madre a figlio durante la gravidanza, il parto o l’allattamento rimane comune. Infetto Donna sieropositiva può dare alla luce sia persone infette da HIV che bambino sano. Secondo le statistiche, su 100 bambini nati da donne infette da HIV, in media, il 30% dei bambini viene infettato, di cui dal 5 all'11% si infetta nell'utero, il 15% durante il parto, il 10% durante l'allattamento e il 70% dei casi il bambino non è infetto. La diagnosi non viene fatta fino a quando il bambino non ha 3 anni. Ciò è spiegato dal fatto che gli anticorpi contro l'HIV della madre rimangono nel sangue del bambino per tre anni e, se successivamente scompaiono, il bambino è considerato HIV negativo, ma se compaiono i suoi anticorpi, viene rilevata l'infezione e il bambino è considerato sieropositivo. L'HIV si trasmette in tre modi: attraverso il contatto sessuale, attraverso il sangue di una persona infetta o da una madre infetta a suo figlio.
Quale dei seguenti elenchi è pericoloso e quale è sicuro?
- Puntura di zanzara.
- Utilizzando un bagno pubblico.
- Baciami sulla guancia.
- Prendersi cura delle persone affette da AIDS.
- Usare lo spazzolino da denti di qualcun altro.
- Applicazione di un tatuaggio.
- Piercing all'orecchio.
- Rapporti sessuali multipli.
- Trasfusione di sangue.
- Morso di cimice.
- Nuotando nella piscina.
- Abbracci con un malato di AIDS.
“Perché è necessaria una visita medica regolare della popolazione?”
Protezione dal virus. Scienza della virologia
(Messaggi dei Suvoroviti, diapositive n. 35 – 39)
La virologia è la scienza dei virus, studiandone la struttura, la biochimica, la sistematica e il significato. Obiettivi: rilevamento di nuovi agenti patogeni precedentemente inesplorati di malattie umane, animali e vegetali, determinazione delle modalità per combattere i virus e prevenire l'infezione da essi. Edward Jenner, medico di campagna inglese (1798), gettò le basi per l'uso di massa delle vaccinazioni e dei metodi di vaccinazione.
La nascita della virologia moderna risale agli anni '50 del XX secolo, quando fu creato il vaccino antipolio e furono sviluppati metodi per la coltivazione continua di ceppi di cellule umane viventi in vitro. È così che è stato trovato un sistema biologico per far crescere il virus in grandi quantità per lo studio e la produzione di massa di un vaccino. Lo sviluppo della microscopia elettronica ha permesso di studiare la struttura morfologica e chimica dei virus, il meccanismo della loro riproduzione e l'interazione con la cellula ospite. La ricerca in citologia, biologia molecolare e genetica ha contribuito allo sviluppo della virologia.
Problemi di virologia:
- trovare disponibile e mezzi efficaci lotta alle malattie virali;
- creazione di farmaci a lungo termine e profilattici che proteggono il corpo dalle infezioni;
- delucidazione del ruolo delle infezioni virali latenti e del trasporto del virus;
- studio delle possibilità di virogenesi per risolvere problemi di ingegneria genetica.
V. Riassumendo(2 minuti.)
Ricordiamo l'argomento della nostra lezione di oggi, l'obiettivo e la domanda problematica che vi abbiamo posto oggi: (diapositiva 40)
Domanda problematica.Perché è difficile combattere i virus che causano malattie e distruggerli completamente? Cosa devi sapere per evitare le malattie virali?
Ma i virus - e tutti lo sanno,
Tra gli altri vivono e prosperano -
La triste realtà è questa!
L'AIDS ci minaccia: come proteggerci?!
E l'influenza aviaria è apparsa all'improvviso da qualche parte!
Come rendere smussata una spada
Ma lo scudo è rimasto impenetrabile!
Guardiamo indietro!
La natura è come un nascondino,
Gioca con il destino umano.
E gli piace raccontarci enigmi,
Un enigma sempre più difficile dopo l'altro!
È come una prova di forza
La razza umana passa dalla Natura,
E disperde con mano generosa
Sta soffrendo per l'umanità.
E guarda senza staccare gli occhi,
Sopravviverà questa volta?!
Ma sopravvisse, sconfisse la peste e il vaiolo,
Colera e difterite sconfitti,
E il filo della vita si affermò degnamente,
Anche se non è stato affatto facile!
Per secoli, aumentando la conoscenza,
Diventando più saggio di secolo in secolo,
L'uomo arrivò alla comprensione,
Lo scopo della tua missione.
È semplice! Viviamo in pace con la Natura
Siamo obbligati a non conquistarla!
VI. Consolidamento.(5 minuti)
Come rinforzo, discutere le domande ricevute per i gruppi. (Sl ID42).
VII. Riflessione(30 secondi) (Diapositiva 44).
E alla fine della nostra lezione, esprimi la tua opinione al riguardo, sul tuo benessere durante la lezione, sui tuoi amici e sul lavoro con loro. Puoi utilizzare i seguenti suggerimenti:
Oggi ho scoperto...
Ero sorpreso...
Ora posso...
Vorrei...
VIII. Compito per s/p: paragrafo 35, condurre una mini-ricerca sulla domanda: “Perché qualcosa che infetta i programmi informatici viene anche chiamato virus?”
Vorrei concludere la nostra lezione con le parole “Carta Mondiale per la Natura”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1982)
“Ogni forma di vita è unica e richiede rispetto, indipendentemente dal suo valore per l’uomo.”
Bibliografia
- Vaseneva E.V. "I virus sono forme di vita non cellulari" 9a elementare.
- Karpusheva A.E. “Virus” 10a elementare. Istituzione educativa municipale Susaninskaya Scuola superiore
- Lyasota S.I. "I virus sono forme di vita non cellulari" 10a elementare. Scuola secondaria KSU n. 2, Taiynsha.
- Ponomareva I.N. Livello del profilo di biologia generale dell'11° grado.
5.1. afta epizootica (V.L. Krupalnik)
5.2. Rabbia (V.L. Krupalnik)
5.3. Vaiolo e malattie simili al vaiolo (N.A. Masimov)
5.3.1. Vaiolo bovino
5.3.2. Paravaccino
5.3.3. Vaiolo ovino e caprino
5.3.4. Stomatite pustolosa contagiosa (dermatite) di pecore e capre
5.3.5. Mixomatosi del coniglio
5.4. Stomatite vescicolare (A. A. Glushkov)
5.5. La malattia di Aujeszky (A. A. Vashutin)
5.6. Peste bovina (A. A. Glushkov)
5.7. Leucosi bovina (N.A. Masimov)
5.8. Febbre catarrale maligna (A. A. Glushkov)
5.9. Rinotracheite infettiva bovina (I. A. Masimov)
5.10. Diarrea virale bovina (N.A. Masimov)
5.11. Infezione respiratoria sinciziale (NA. Masimov)
5.12. Parainfluenza bovina-3 (NA. Masimov)
5.13. Infezione da coronavirus (diarrea) nei vitelli (UN. IO. Kurylenko, V. L. Krupalnik)
5.14. Infezione adenovirale dei vitelli
5.15. Infezione da rotavirus vitelli (A. N. Kurylenko, V. L. Krupalnik)
5.16. Infezione da parvovirus nei vitelli (A. N. Kurylenko, V. L. Krupalnik)
5.17. Infezioni virali lente (A. A. Sidorchuk)
5.17.1. Pecore e capre Visna-madi
5.17.2. Adenomatosi degli ovini e caprini
5.17.3. Artrite-encefalite delle capre
5.18. Peste suina (M. A. Sidorov, V. L. Krupalnik)
5.19. Peste suina africana (M.A. Sidorov)
5.20. Gastroenterite virale suina (M.A. Sidorov)
5.21. Encefalomielite enzootica suina (V.L. Krupalnik)
5.22. Malattia vescicolare del suino (M.A. Sidorov)
5.23. Esantema vescicolare suino (V.L. Krupalnik)
5.24. Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (G. IO. Kuzmin, T. E. Solovyova)
5.25. Malattia da parvovirus suino (G. IO. Kuzmin, T. E. Solovyova)
5.26. Influenza suina (M.A. Sidorov)
5.27. Enterite da rotavirus dei suinetti (A. I. Kurylenko, V. L. Krupalnik)
5.28. Influenza equina (Ya. A. Masimov)
5.29. Anemia infettiva dei cavalli (I. A. Masimov)
5.30. Peste equina africana (N.A. Masimov)
5.31. Rinopolmonite equina (N.A. Masimov)
5.32. Encefalite infettiva (encefalomielite) dei cavalli (A. A. Glushkov)
5.33. Peste dei carnivori (Ya. A. Masimov)
5.34. Epatite infettiva (virale) dei carnivori (N.A. Masimov)
5.35. Malattia del visone delle Aleutine (I. A. Masimov)
5.36. Enterite virale del visone (N.A. Masimov)
5.37. Enterite da parvovirus canino (N.A. Masimov)
5.38. Panleucopenia felina (I. A. Masimov)
5.39. Rinotracheite felina (I. A. Masimov)
5.40. Infezione da calicivirus dei gatti (I. A. Masimov)
5.41. Malattia emorragica virale del coniglio (N.A. Masimov)
6. Infezioni da prioni(A. A. Sidorchuk)
6.1. caratteristiche generali Prioni e infezioni da prioni
6.2. Encefalopatia spongiforme bovina
6.3. scrapie
6.4. Encefalopatia del visone
7. Malattie degli animali causate da funghi(A.F. Kuznetsov)
7.1. Caratteristiche generali delle malattie causate da funghi
7.2. Micosi
7.2.1. Dermatomicosi
7.2.1.1. Tricofitosi
7.2.1.2. Microsporosi
7.2.2. Micosi classiche
7.2.2.1. Candidosi
7.2.2.2. Linfangite epizootica
7.2.2.3. Blastomicosi
7.2.3. Micosi da muffe
7.2.3.1. Aspergillosi
7.2.3.2. Penicillomicosi
7.2.3.3. Mucormicosi
7.2.4. Pseudomicosi
7.2.4.1. Actinomicosi
7.2.4.2. Actinobacillosi
7.2.4.3. Dermatofilosi
7.2.4.4. Nocardiosi
7.2.5. Trattamento degli animali affetti da micosi
7.3. Micotossicosi
7.3.1. Aspergillotossicosi
7.3.2. Penicillotossicosi
7.3.3. Stachibotriotossicosi
7.3.4. Dendrodochiotossicosi
7.3.5. Fusariotossicosi
7.3.6. Tossicosi da clavicepso
8. Malattie degli uccelli(BF Bessarabov)
8.1. Malattia di Newcastle
8.2. La malattia di Marek
8.3. Laringotracheite infettiva
8.4. Vaiolo degli uccelli
8.5. Sindrome da produzione ridotta di uova-76
8.6. Influenza aviaria
8.7. Bronchite infettiva dei polli
8.8. Malattia infettiva della borsa
8.9. Infezione da paramixovirus
8.10. Epatite virale degli anatroccoli
8.11. Enterite virale delle oche
8.12. Anemia infettiva dei polli
8.13. Encefalomielite infettiva aviaria
8.14. Peste delle anatre
8.15. Leucosi degli uccelli
8.16. Psittacosi
8.17. Pullorosi
8.18. Salmonellosi
8.19. Micoplasmosi respiratoria
9. Malattie dei pesci(L. I. Grishchenko)
9.1. Viremia primaverile della carpa
9.2. Setticemia emorragica virale
9.3. Vaiolo della carpa
9.4. Pseudomonosi
9.5. Aeromonosi della carpa
9.6. Foruncolosi
9.7. Branchiomicosi
10. Malattie delle api(O. F. Grobov)
10.1. Peste americana
10.2. Peste europea
10.3. Sacbrood
10.4. Paralisi virale
10.4.1. Paralisi virale cronica
10.4.2. Paralisi virale acuta
10.4.3. Paralisi virale lenta
10.5. Enterobatteriosi
10.5.1. Afniosi
10.5.2. Escherichiosi
10.5.3. Salmonellosi
10.6. Spiroplasmosi
10.7. Aspergillosi
10.8. Ascoferosi
10.9. Melanosi
DIZIONARIO DELLE ABBREVIAZIONI
PSA – Peste suina africana
AHS: peste equina africana
AEC - artrite-encefalite delle capre
BM – La malattia di Marek
BN – Malattia di Newcastle
VDS – malattia vescicolare del suino
VVC - viremia primaverile della carpa
VHD - malattia emorragica virale dei conigli
VGU - gastroenterite virale degli anatroccoli
PGE: gastroenterite virale suina
VD - diarrea virale
BS - malattia delle mucose
BLVRS - virus della leucemia bovina
VES - esantema vescicolare suino
G + C - guanina + citosina
GOA - idrossido di alluminio
SE - encefalopatia spongiforme
DNA - acido desossiribonucleico
Tratto gastrointestinale - tratto gastrointestinale
MCG: febbre catarrale maligna
IAR - rinite atrofica infettiva
IBD: malattia infettiva della borsa
IBK - bronchite infettiva (o borsite) dei polli
IKK - cheratocongiuntivite infettiva
ILT - laringotracheite infettiva
INAN – anemia infettiva
IRT - rinotracheite infettiva
ELISA - test immunoenzimatico
IEM - encefalomielite infettiva
IEML – encefalomielite infettiva equina
NEP – encefalomielite infettiva aviaria
KA: agar sangue
KAM - complesso di micobatteri atipici
CCRA - reazione di agglutinazione delle gocce di sangue
KKRNHA - reazione delle gocce di sangue di emoagglutinazione indiretta
CPP - pleuropolmonite contagiosa (peripolmonite)
KPPK - pleuropolmonite contagiosa delle capre
KR - reazione ad anello
KRS - grande gatto cornuto
TC - coltura tissutale
CSF - peste suina classica
CE - embrione di pollo
ME - unità internazionale
MKM - farina di carne e ossa
MPA - agar con estratto di carne
MPB - brodo di carne e peptoni
MPPB - brodo di fegato di carne e peptoni
Piccoli bovini - piccoli ruminanti
MFA - metodo con anticorpi fluorescenti
OIE - Ufficio internazionale delle epizoozie
NIVS - stazione veterinaria di ricerca
NIHI - Istituto di ricerca agricola
NPO - associazione scientifica e produttiva
PVIS – infezione da parvovirus suino
PG-3 - parainfluenza-3
SGR - indicatore di ritardo nella crescita
PMV - paramixovirus
PMI – infezione da parmyxovirus
PPD - derivato purificato proteico (purificato a secco)
PCR - reazione a catena della polimerasi
RA - reazione di agglutinazione
RAVS - reazione di agglutinazione con muco vaginale
RBP - campione di rosa bengala
RHA - reazione di emoagglutinazione
RGAd - reazione di emoassorbimento
RDP - reazione di precipitazione per diffusione
RDSC - reazione di fissazione del complemento a lungo termine
RZHA - reazione ritardata dell'emoagglutinazione
RZGAd - reazione ritardata di emoassorbimento
RHR - reazione di ritardo della crescita
RID - reazione di immunodiffusione
RIF - reazione di immunofluorescenza
RIEOF - reazione di immunoelettroosmoforesi
RM - micoplasmosi respiratoria
PMA - reazione di microagglutinazione
RNAb - reazione di neutralizzazione degli anticorpi
RNHA - reazione di emoagglutinazione indiretta
RNA - acido ribonucleico
PRRS - sindrome riproduttiva e respiratoria del suino
RSI - infezione respiratoria sinciziale
RSK - reazione di fissazione del complemento
HRTHA - reazione di inibizione dell'emoagglutinazione
RTGAd - reazione di inibizione dell'emoadsorbimento
RTNHA - reazione di inibizione indiretta dell'emoagglutinazione
RES - sistema reticoloendoteliale
VES - velocità di sedimentazione degli eritrociti
SPF - esente da flora patogena
EDS – sindrome da ridotta produzione di ovociti
CHAO - membrana corion-alantoidea
SNC - sistema nervoso centrale
CPD - effetto citopatogeno
EES - encefalomielite enterovirale suina
EEMS - encefalomielite enzootica dei suini
BSE - Encefalopatia spongiforme bovina (encefalopatia spongiforme bovina)
ELISA - test immunoenzimatico
PgR - prione
PREFAZIONE
Disciplina "Epizootologia e malattie infettive“- uno degli aspetti più importanti nella formazione di un veterinario. L'ultimo libro di testo sull'epizootologia, a cura del professor A. A. Konopatkin, è stato pubblicato 14 anni fa, nel 1993. Attualmente è diventato praticamente inaccessibile e il materiale in esso presentato è significativamente obsoleto. Epizootologi e specialisti in malattie infettive delle università e facoltà veterinarie del nostro paese parlano da diversi anni della necessità di scrivere un nuovo libro di testo per gli studenti universitari su questo argomento.
Il libro di testo "Epizootologia generale" è stato pubblicato dalla casa editrice "KolosS" nel 2004. Questo libro di testo "Malattie infettive degli animali", che in realtà è la sua continuazione, è stato scritto da un team di specialisti, importanti professori di istituti di ricerca e insegnanti di dipartimenti di epizootologia e malattie infettive di numerose università in Russia (MSAVMiB, San Pietroburgo. GAVM, Kazan GAVM, Università agraria statale di Voronezh, Università agraria statale di Omsk, VIEV) in conformità con lo standard educativo statale (GOS) di livello superiore formazione professionale, approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione russo dal Programma della disciplina “Epizootologia e malattie infettive” e tenendo conto dei dati più recenti sulla patologia infettiva degli animali.
Questo libro di testo comprende circa 150 unità nosologiche. Il materiale su tutte le malattie è presentato secondo un unico schema generalmente accettato. Un articolo separato è dedicato a ciascuna malattia. Il libro presenta costantemente informazioni su malattie batteriche, virali, fungine e di altro tipo. Per i singoli capitoli all'inizio di un gruppo di malattie correlate (ad esempio clostridiosi, clamidia, micoplasmosi, rickettsiosi, micosi, ecc.), viene fornita una breve descrizione per una comprensione più profonda delle loro cause comuni.
Il nome della malattia è dato in russo, latino e Lingue inglesi, vengono forniti i principali sinonimi russi. La definizione della malattia con le sue principali caratteristiche è evidenziata con una frase chiave all'inizio di ogni articolo. Per ciascuna malattia viene fornito il nome tassonomico moderno dell'agente patogeno, viene fornita una descrizione dei suoi tipi e varianti, indicando le principali proprietà importanti per comprendere il processo infettivo e vengono forniti dati sulla resistenza ai principali fattori fisico-chimici, che è importante per comprendere le problematiche relative al mantenimento dell'agente patogeno nell'ambiente esterno e all'azione dei disinfettanti.
Vengono prese in considerazione le informazioni sulla diffusione della malattia in tutto il mondo, la sua presenza (ampiezza di distribuzione) o assenza sul territorio della Russia, il pericolo epizootologico ed economico della malattia, nonché la patogenesi. Questo materiale ha un valore ausiliario.
“Epizootologia” presenta i dati epizoologici più importanti sulla malattia: suscettibilità per specie ed età, fonti e serbatoi dell’agente infettivo, modalità di infezione e meccanismo di trasmissione, intensità del processo epizootico, stagionalità e periodicità, significato dei fattori predisponenti, morbilità e mortalità (mortalità).
Idee su periodo di incubazione, la natura del decorso e le forme cliniche di manifestazione della malattia si riflettono in “Corso e manifestazione clinica”. Le caratteristiche dei sistemi corporei più colpiti, i segni clinici caratteristici di vari tipi animali (se la malattia è comune ad animali di specie diverse), viene indicato l'esito della malattia.
I “Segni patoanatomici” delineano i macrocambiamenti più caratteristici (patognomonici) degli organi e dei tessuti con una breve indicazione dei cambiamenti generali. Tra i cambiamenti patologici, la massima importanza è attribuita a quelli che hanno valore diagnostico.
"Diagnostica e diagnosi differenziale" è dedicata ai principali metodi diagnostici, sulla base dei quali viene stabilita una diagnosi preliminare e finale. Viene indicato quale materiale patologico deve essere inviato al laboratorio per la ricerca. Viene fornito un collegamento a current regolamenti, in conformità con il quale eseguono diagnostica di laboratorio e indicatori obbligatori in base ai quali la diagnosi è considerata stabilita. Nel rispetto di diagnosi differenziale Vengono elencati i nomi delle principali malattie (contagiose e non contagiose) simili a quella descritta.
Inoltre, per ciascuna malattia in “Immunità, Prevenzione Specifica” vengono annotate le possibilità, i tempi di formazione, la durata e l'intensità dell'immunità post-infettiva e post-vaccinazione. Vengono fornite brevi informazioni sui prodotti biologici utilizzati e sulla loro efficacia senza indicare il dosaggio, la frequenza delle vaccinazioni, i tempi di vaccinazione e i luoghi di somministrazione dei vaccini e dei sieri, tenendo conto del fatto che tali informazioni sono riportate nelle istruzioni (manuali) per l'utilizzo di prodotti biologici, che sono necessariamente allegati ad ogni confezione.
La “Prevenzione” stabilisce uno schema per l'organizzazione e l'attuazione di misure preventive generali e specifiche per questa malattia in conformità con i requisiti moderni e le norme attuali (istruzioni).
Il “trattamento” riflette le misure terapeutiche specifiche più importanti e i farmaci utilizzati in questo caso senza indicare dosi, regimi e metodi, poiché queste informazioni sono molto estese e costantemente aggiornate. Il lettore può ottenere informazioni sulle forme dei farmaci, sui dosaggi e sui metodi di utilizzo da numerosi libri di consultazione e manuali di farmacologia e chemioterapia.
Le "Misure di controllo" descrivono schemi di misure per eliminare la malattia in conformità con le attuali norme (istruzioni) del Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa. Sono indicate la natura delle misure restrittive, la loro durata, le manipolazioni con animali malati (possibilità e fattibilità del trattamento, macellazione, distruzione), la possibilità di utilizzare materie prime, prodotti, mangimi e rifiuti; norme per lo smaltimento delle salme, dei rifiuti animali e del letame e per l'esecuzione di misure veterinarie e sanitarie. Per le malattie comuni agli animali e all'uomo, alla fine di ogni articolo è riportata una sintesi delle misure a tutela della salute umana.
Professore A. A. Sidorchuk
Virus umani e animali
Di che tipo di virus soffre una persona? Alcuni colpiscono le vie respiratorie, moltiplicandosi nel rinofaringe, nella trachea e nei bronchi, raggiungendo spesso i polmoni. Altri preferiscono depositarsi nell'intestino, provocando diarrea o, semplicemente, diarrea. I virus neurotropi penetrano nelle cellule nervose. Alcuni dei più virus pericolosi- Questi sono gli agenti causali delle febbri emorragiche. Attaccano le pareti dei vasi sanguigni, provocando gravi problemi circolatori. Alcuni virus causano tumori.
Dove iniziare?
Cominciamo dal virus dell'influenza. Perché l'influenza è la malattia virale più comune nell'uomo e una delle più pericolose. Il 90% di tutte le infezioni sono influenzali e malattie respiratorie simil-influenzali. E in termini di danni economici che provoca, l’influenza è al primo posto tra le malattie. Quindi, l'influenza.
L'influenza dura non più di due settimane, ma è molto pericolosa. Si ritiene che ogni esperienza influenzale riduca la vita di un anno: il carico su tutto il corpo con questa malattia è così grande.
Ora sono conosciuti 3 tipi di virus influenzali: A, B e C (queste lettere sono latine, quindi in russo si pronunciano come “a”, “b” e “c”). Il nucleo del virione contiene il materiale genetico del virus: otto molecole di RNA a filamento singolo. Ciascuno di essi è racchiuso in un involucro proteico e rappresenta un gene separato. Tutto questo è racchiuso in un guscio comune della cosiddetta proteina “M”, sopra il quale ce n'è un altro costituito da lipidi. Il guscio lipidico è permeato da due tipi di proteine: emoagglutinina e neuraminidasi, che all'interno del virione sono ancorate alla proteina M, e all'esterno, come punte, sporgono molto al di sopra della superficie della particella virale. Sebbene l'immagine mostri una particella sferica del virus dell'influenza, in realtà la sua forma è variabile e le particelle filiformi non sono rare.

Micrografia elettronica delle particelle del virus dell'influenza
Il virus viene trasmesso da una persona malata a una persona sana mediante goccioline trasportate dall'aria o, come si dice anche, aerogenamente, insieme a goccioline di saliva e muco che volano via quando si tossisce e si starnutisce. Una volta sulla superficie mucosa delle vie respiratorie, il virus, senza pensarci due volte, invade le cellule epiteliali. Naturalmente, nessun virus entrerà in una cellula in questo modo. Ma il virus dell'influenza ha una chiave: la stessa emoagglutinina. Con il suo aiuto, il virus determina se la cellula è adatta all'infezione e, se idonea, apre la porta d'ingresso. L'involucro lipidico del virus e la membrana esterna della cellula ospite sono strutturati in modo identico e si fondono volentieri in uno solo. Avendo così lasciato gli indumenti esterni all'ingresso, il virus seminudo entra nel citoplasma della cellula e si mette all'opera, cioè alla formazione di nuove particelle virali figlie. Le cellule in cui può penetrare il virus dell'influenza sono sparse su tutta la superficie del tratto respiratorio, ma la maggior parte di esse si trova nella trachea.

Schema della struttura del virus dell'influenza: 1 – RNA virale nel nucleo del virione; 2 – guscio proteico (capside); 3 – membrana lipidica; 4 – emoagglutinina; 5 – neuraminidasi
Abbastanza rapidamente, arriva il momento in cui si sono già raccolte abbastanza nuove particelle virali e non c'è più niente da prendere dalla cellula. A quel punto, la sua membrana esterna, come gli spilli, è letteralmente tempestata di proteine virali, anch’esse prodotte in Cina grandi quantità. I virioni della figlia indossano un nuovo vestito esterno e lasciano la cellula strappata, sbocciando da essa. L'ultimo ponte, che collega ancora le superfici cellulari e virali, viene distrutto dalla neuraminidasi virale. Il germogliamento è un metodo di separazione relativamente delicato, quindi la cellula abbandonata non sempre muore. Alcuni riescono a guarire e a sopravvivere, ma la maggior parte muore comunque a causa dell’infezione.
Di solito il numero di cellule inizialmente infette non è troppo grande, quindi il corpo non si accorge immediatamente del loro danno. Questo periodo, in cui non sentiamo ancora l’invasione, si chiama incubazione. L'influenza ha una breve durata di 12-48 ore. Ma poi c'è un massiccio rilascio di virioni maturi nello spazio intercellulare. Frammenti di cellule distrutte e proteine virali vengono trasportati in tutto il corpo dal sangue, avvelenandolo. Debolezza generale, debolezza, dolori, depressione, sudorazione e aumento della fragilità dei vasi sanguigni, grave mal di testa- insomma i sintomi, ben noti a tutti, sono una conseguenza di questo avvelenamento. Un forte aumento della temperatura corporea è la prova che il il sistema immunitario. E in realtà sul luogo dell'invasione accade quanto segue. Il tratto respiratorio è rivestito da cellule ciliate. Altre cellule, chiamate cellule caliciformi per la loro forma caratteristica, secernono muco. Le ciglia eseguono continuamente movimenti ritmici, a seguito dei quali il film di muco si muove in una direzione, verso l'esterno. Tutto ciò che entra nelle vie respiratorie con l'aria inalata viene avvolto nel muco e portato fuori dal corpo. La stessa sorte attende le cellule distrutte dal virus. Ma poiché ce ne sono molti, è necessario agire in modo rapido e deciso e la tosse è l'unico modo per far fronte a questo compito.

Il virus dell'influenza viene catturato dalla membrana cellulare (1). La membrana lipidica del virus e la membrana cellulare si fondono . All'interno della vescicola è presente un capside virale nudo (2). Gli RNA virali emergono dal capside virale distrutto nel citoplasma e si mettono al lavoro (3). Le particelle virali figlie si precipitano verso la membrana cellulare , costellato di proteine virali di nuova produzione – emoagglutinina e neuraminidasi (4). Una particella virale matura germoglia da una cellula (5)
I batteri patogeni, soprattutto gli pneumococchi, si insinuano nelle enormi fessure che appaiono nel rivestimento delle vie respiratorie a causa della morte delle cellule infette. Con l'influenza si verificano varie complicazioni, ma la polmonite, cioè la polmonite, è la più comune e la più pericolosa. Inoltre, il virus dell’influenza sopprime il sistema immunitario umano, facilitando ulteriormente l’espansione di altri agenti patogeni.
L'influenza provoca un'esacerbazione di molte malattie croniche. Spesso una persona muore pochi mesi dopo aver avuto l'influenza. Si ritiene che sia morto per colpa sua malattia cronica. Infatti è morto di influenza.
L'influenza colpisce più spesso i bambini e sono loro la principale fonte di infezione. Le persone sopra i sessanta hanno meno probabilità di ammalarsi. Tuttavia, il tasso di mortalità per influenza è più basso nei bambini e più alto negli anziani. Due terzi di tutti i decessi per influenza si verificano in questa fascia di età. La mortalità per influenza è elevata anche nei bambini di età compresa tra 6 e 12 mesi. A questa età, l'immunità ricevuta dalla madre non funziona più e la tua non ha ancora avuto il tempo di svilupparsi.
Dal libro Biologia [Libro di consultazione completo per la preparazione all'esame di stato unificato] autore Lerner Georgy Isaakovich4.2. Regno dei batteri. Caratteristiche della struttura e dell'attività vitale, ruolo nella natura. I batteri sono agenti patogeni che causano malattie nelle piante, negli animali e nell’uomo. Prevenzione delle malattie causate da batteri. Virus Termini e concetti di base testati nel documento d'esame:
Dal libro Il più recente libro dei fatti. Volume 1. Astronomia e astrofisica. Geografia e altre scienze della terra. Biologia e medicina autore Kondrashov Anatoly Pavlovich4.6. Il regno degli animali. Le principali caratteristiche dei sottoregni degli animali unicellulari e multicellulari. Animali unicellulari e invertebrati, loro classificazione, caratteristiche strutturali e funzioni vitali, ruolo nella natura e nella vita umana. Caratteristiche delle principali tipologie
Dal libro Guida alla raccolta dei funghi autore Onishchenko Vladimir4.7. Animali cordati, loro classificazione, caratteristiche strutturali e funzioni vitali, ruolo nella natura e nella vita umana. Caratteristiche delle principali classi di cordati. Comportamento animale 4.7.1. Caratteristiche generali del tipo cordato Termini e concetti di base testati in
Dal libro Esploro il mondo. Virus e malattie autore Chirkov S.N.6.5. Origini umane. L'uomo come specie, il suo posto nel sistema del mondo organico. Ipotesi di origine umana. forze motrici e le fasi dell’evoluzione umana. Razze umane, la loro relazione genetica. Natura biosociale dell'uomo. Ambiente sociale e naturale,
Virus e cancro negli esseri umani Gli animali sono sottoposti costantemente all'autorinnovamento dei tessuti per tutta la loro vita a causa della crescita e divisione cellulare limitata e controllata. Le vecchie cellule muoiono quando il timer che scorre al loro interno interrompe la loro capacità di dividersi; il loro posto
Dal libro dell'autorePapillomavirus umani I papillomavirus umani sono piccoli virus sferici, che a prima vista hanno una struttura piuttosto semplice. Il loro DNA circolare a doppio filamento, contenente solo nove geni, è racchiuso in un guscio proteico sferico di diametro
Dal libro dell'autoreVirus Probabilmente hai sentito parlare di virus dell'influenza, della rabbia, dell'herpes e dell'AIDS. Questi virus causano malattie negli esseri umani e negli animali. Esistono malattie virali delle piante, come il mosaico del tabacco, in cui le foglie del tabacco si ricoprono di macchie biancastre. Anche
Dal libro dell'autoreVirus “benefici” Non bisogna pensare che i virus causino solo problemi alle persone. Con l'aiuto dei virus sono state ottenute numerose varietà di fiori, il cui colore variegato è il risultato di un'infezione virale trasmessa di generazione in generazione. La variegatura dei tulipani provoca
Le malattie che possono essere trasmesse dagli animali all'uomo sono chiamate "zoonosi", "antropozoonosi" o "zooantroposi". La diagnosi di tali malattie è piuttosto difficile, poiché i medici generici (non i veterinari) spesso non sono consapevoli di come una particolare malattia viene trasmessa da un animale a una persona e non sono sempre in grado di riconoscerla e prescrivere correttamente il trattamento. Pertanto è semplicemente fondamentale sapere da dove può derivare la zoonosi, come si manifesta e come prevenire l’infezione. La maggior parte delle infezioni sono comuni nei paesi caldi dove non è consuetudine lavarsi le mani e vaccinarsi. Leggi informazioni su rabbia, ittero infettivo, elminti, protozoi e tigna. Imparerai anche perché gli animali non possono infettare il loro proprietario con polmonite, virus come l'influenza e demodicosi.
RABBIA
La rabbia è la zoonosi più conosciuta e diffusa. Si tratta di un virus neurotropico che si trasmette attraverso la saliva e colpisce il cervello, provocando convulsioni che portano alla morte.
Vale la pena notare che la sbavatura attiva in un animale non è sempre un segno di rabbia. Ad esempio, il gatto può sbavare di piacere quando viene accarezzato, oppure avere un sapore amaro se ha masticato un ramo di pioppo.
Fonte di infezione.
I portatori del virus della rabbia sono solitamente animali selvatici o randagi. Cosa c'entra questo con tutti gli animali selvatici: e anche con i simpatici ricci che potrebbero vagare accidentalmente nella dacia.
Il termine medico "salivazione di un animale rabbioso" significa che la persona non è stata morsa, ma è stata macchiata di saliva.
Come evitare l'infezione?
Evitare il contatto con animali selvatici e randagi. Se ti piace un gatto o un cane randagio, osservalo per due settimane o più prima di prenderlo in cura. Se possibile, chiedi a coloro che hanno già visto l'animale se ci sono state deviazioni nel comportamento. Poiché la rabbia non ha cura, gli animali domestici devono essere vaccinati contro la rabbia.
Come si riconosce la rabbia?
Riconoscere stato iniziale Questa malattia è impossibile perché il portatore del virus inizia a diffonderlo 3-14 giorni prima di sviluppare i sintomi. Un animale infetto dalla rabbia tende a comportarsi in modo violento. Ma nei gatti questa malattia è asintomatica.
Gli animali sospettati di avere la rabbia vengono messi in quarantena fino a 40 giorni: se sono infetti moriranno, altrimenti vivranno.
Sfortunatamente, una volta che compaiono i segni della rabbia nelle persone, è anche impossibile curarli. Pertanto, subito dopo un morso o una salivazione, è necessario somministrare il vaccino. In precedenza, venivano eseguite 40 iniezioni nello stomaco, ora tutto è più semplice: un ciclo di 6 iniezioni nella spalla.
LEPTOSPIROSI o
ITTERO INFETTIVO
La leptospirosi è causata dal batterio a forma di spirale Leptospira, che di solito viene trasmesso attraverso l'urina. Il loro luogo di riproduzione preferito è il corpo dei mammiferi, così come l'acqua stagnante nella stagione calda.
 Fonte di infezione.
Fonte di infezione.
Questi batteri entrano nel corpo umano o animale insieme all'acqua contaminata. L'acqua stessa può essere contaminata da chiunque, ma più spesso si tratta di mucche, maiali, topi e ratti che vivono nelle vicinanze.
Sia le persone che gli animali domestici possono contrarre la leptospirosi, ad eccezione dei gatti.
Anche i cani non infettano gli specchi d'acqua con la leptospirosi, poiché non urinano mentre nuotano; per fare ciò hanno bisogno di sedersi o alzare la zampa.
Di norma, la persona stessa può defecare mentre fa il bagno.
Come evitare l'infezione da leptospirosi?
Non lasciare che i cani bevano dalle vecchie pozzanghere. Non puoi nuotare in stagni di fuoco o in specchi d'acqua stagnanti.
Dovresti soprattutto diffidare di quei corpi idrici che si trovano vicino alle fattorie.
Cani e furetti dovrebbero essere vaccinati.
A differenza della rabbia, la leptospirosi compare dal secondo al quinto giorno. Gli animali avvertono debolezza, mancanza di appetito, mancanza di respiro, odore sgradevole dalla bocca, a volte vomito con sangue e diarrea.
La temperatura di una persona aumenta, compaiono mal di testa, dolori muscolari e brividi, come nella meningite. Contrariamente al nome, l'ittero è raro.
La presenza di Leptospira può essere rilevata donando il sangue per un apposito test.
La malattia viene curata con antibiotici, che devono essere assunti entro e non oltre il quarto giorno dalla comparsa della malattia, altrimenti sarà fatale.
ELMINTI e PROTISTI
(protozoi)
TIGNA
La tigna è causata da tipi diversi funghi - Trichophyton e Microsporum. Solo un medico può distinguere le loro manifestazioni.
Fonte di infezione da tigna.
Normalmente, sulla pelle umana e sul pelo degli animali sono sempre presenti vari funghi. Se il sistema immunitario è sano, non cresceranno.
Questa infezione prospera negli animali indeboliti, inclusi vecchi, giovani, cronicamente indeboliti, scarsamente nutriti e che vivono in condizioni antigeniche.
Pertanto, contattando animali randagi, potresti essere infettato.
Anche volpi, cani procione, ecc. possono contrarre la tigna.
Non toccare con le mani animali sconosciuti, soprattutto quelli rognosi.

Come identificare la tigna negli animali?
Cominciano ad apparire macchie a forma di anelli o cerchi. Possono essere di colore rosso vivo o grigio, con croste infiammate. Le macchie stesse pruriscono in modo insopportabile e i capelli cadono naturalmente nella zona interessata. I non specialisti possono confondere il lichene con un'allergia alimentare o una carenza vitaminica. Sono finiti i tempi in cui si credeva che un animale malato dovesse essere sottoposto ad eutanasia. La tigna può essere curata con un trattamento adeguato.
Cosa fare?
La cosa più importante è non perdere tempo e raschiare al primo sospetto. Se l'analisi non rivela il fungo, non affrettarti. Ripeti il test tra una settimana.
I moderni farmaci antifungini trattano efficacemente i licheni, ancora più facilmente negli animali che negli esseri umani. A volte spalmare le macchie con una soluzione di iodio ha un buon effetto.
Cani, gatti e furetti possono essere vaccinati preventivamente, ma solo contro un tipo di fungo: il Trichophyton.
Perché gli animali non possono infettare il loro proprietario
polmonite, virus di tipo influenzale, demodicosi?
Essere infettato POLMONITEÈ impossibile per una persona ottenere da un animale. Cani, gatti e ratti addomesticati possono effettivamente avere micoplasmi, batteri che vivono sulla mucosa delle vie respiratorie. Ma il micoplasma animale è diverso dal micoplasma umano. Ce ne sono più di 40 e quelli che si depositano sulle mucose degli animali non vengono trasmessi all'uomo, così come dall'uomo agli animali.
VIRUS DI TIPO INFLUENZALE Anche l'influenza umana è diversa dall'influenza animale.
DEMODECOSI Inoltre non viene trasmesso dagli animali all'uomo. È causato dall'acaro della pelle Demodex. Questo acaro può vivere a lungo sulla pelle, ma non si manifesta in alcun modo finché l'immunità di una persona non diminuisce (proprio come malattie fungine). Tuttavia, gli esseri umani e i cani hanno diversi tipi di Demodex, che non vengono trasmessi.